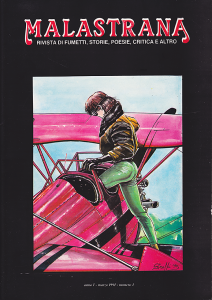non-fiction

Towards a definition of multimediality

Is there a mind in this mind?
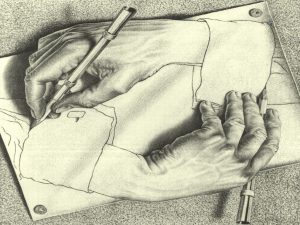
Io, l’autore e il narratore

Total Theatre and the Transformative Potential of Augmented Total Theatre In Arts, Culture, and Education

Augmented Total Theatre: Shaping the Future of Immersive Augmented Reality Representations

Narrativa ipertestuale? Non ancora, grazie!
Gli ipertesti e la comunicazione multimediale

Nota critica: Walter J. Ong – Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola
fiction
Le effemeridi della luna nera
 Tra non molto arriveranno gli ospiti. Le mie guardie si muovono già nel parco con i gesti consueti; girano lente tra le siepi, attorno alla casa, in silenzio; fedeli agli ordini impartiti cercano improbabili intrusi, sorvegliano le entrate. Anch'io voglio verificare che tutto sia a posto; entro nella stanza di controllo e accendo i monitor allineati lungo le pareti in triplice fila; la stanza si riempie di bagliori bianchi, di righe orizzontali che scorrono lente dal basso in alto, di zig-zag disordinati sugli schermi. Sfioro con le dita le file di pulsanti nel pannello di comando, infilo le cassette nei videoregistratori, li accendo, attivo le telecamere una dopo l'altra. Ruotando sulla sedia girevole lancio rapide occhiate alle immagini del parco vuoto, alla piscina illuminata, alla scalinata esterna che conduce fino all'atrio centrale, a due o tre sale sfavillanti di luci, al salone della festa coi tavoli traboccanti di cibi, all'angolo riservato ai musicisti con i leggii già disposti di fronte alle sedie. Su uno degli schermi colgo un movimento, è la scia colorata di un corpo che esce dal campo di uno dei monitor. Subito ruoto la telecamera corrispondente a destra fin quando il giardiniere si staglia controluce al centro del quadro; lo vedo camminare verso la centralina di comando delle fontane, aziona le pompe per gli zampilli e abbassa l'interruttore che controlla le luci del parco. Si allontana. Dietro di lui scorgo i profili dei pini, le strutture intricate dei castagni, i bordi smussati delle siepi. Gli schermi mi rimandano quadri spezzati della villa; ogni cespuglio nel parco, ogni angolo della casa si specchia negli occhi attenti delle mie telecamere, e la villa è come frammentata e moltiplicata davanti a me in miriadi di ville diverse, immagini che trattengo e registro catturando sezioni di spazio sfrondate dal contesto inutile che le circonda. Gli animali nelle gabbie sembrano tranquilli: dormono. Solo una delle scimmie si sveglia d'improvviso al fruscio dell'acqua proiettata in alto. Gira la testa verso il cerchio irregolare che l'acqua in cascata compone nella vasca della fontana più vicina alle gabbie e si gratta la pancia a caccia di qualche pulce fastidiosa. Una guardia si accosta ora alle gabbie, rimane a scrutare gli animali per qualche secondo, poi scuote mollemente la testa prima di riprendere il giro, e mi fa sorridere questo suo gesto di superiorità nei confronti degli animali; le mie telecamere stanno a lui come i suoi occhi stanno alle scimmie; osserva le scimmie con disprezzo senza sapere che è lui, a sua volta, ad essere scimmia per me. A volte mi chiedo quali sarebbero le reazioni dei miei uomini se riuscissero a intuire la verità: che il loro appartenere ai servizi di sicurezza è illusione, un involucro ufficiale opportuno solo a mascherare la mia attività. Ma so che è un pensiero inutile il mio; la loro ottusità già li condanna: non riuscirebbero mai a capire, e quindi non riusciranno mai a sapere. Ciò che veramente conta, il mio lavoro segreto, non li riguarda. Sanno che il controllo è il problema essenziale, e sanno anche che essendo io il capo dei Servizi di Sicurezza devo avere ogni cosa sotto controllo. Questo lo sanno, questo è normale. Ma come controllare, come usare gli strumenti di controllo, perché decidere di guardare, questo non riguarda loro né nessun altro. Il fascino che scaturisce dall'osservazione, quello non potrebbero mai apprezzarlo. Osservare, controllare, proteggere, proteggere tutto come in una cassaforte. Gli oggetti, le persone. Tutto. Osservare le persone come gioielli rari, pietre preziose cariche di movimento proprio e di vita, studiare i loro sguardi, le sequenze interessanti di gesti e parole, i comportamenti pubblici e quelli privati, sgusciare dentro le loro intimità e svelarle come si estrae il corpo lucido di un'ostrica dal suo guscio spalancato. Osservare tutto. Osservare. Capire. E usare le immagini, quando è il caso di farlo. Come in un gioco. Osservarli. Come animali in gabbia, appunto. Lancio un'ultima occh iata ai monitor; tutto è in perfetto ordine. Naturalmente. I primi ad arrivare sono i musicisti. Tutta gente accuratamente selezionata dalla marchesa stessa. Gli uomini indossano vestiti scuri, cravatte nere; le donne sfilano con lunghi abiti da sera scollati che scoprono spalle e lembi di pelle. Con gli astucci degli strumenti in mano ciondolano lenti davanti al cancello, si osservano attorno cauti, forse appena a disagio per il fasto inconsueto che li circonda. Così mi diverto a inseguirli con due o tre telecamere nascoste tra gli alberi, colgo qualche primo piano delle loro espressioni di meraviglia, il muoversi a scatti di qualche testa, un ciuffo biondo di capelli che scivola sulla fronte di una delle donne, il riflesso di una luce in una scarpa di vernice nera, un bagliore bianco. Li seguo mentre avanzano con movimento quasi continuo dagli schermi di sinistra via via a quelli di destra, dall'alto progressivamente in basso man mano che procedono verso l'interno del parco e verso la villa. Mentre uno dei camerieri li accompagna verso il settore della sala riservato ai musicisti, anche gli altri ospiti cominciano ad arrivare e sfilano l'uno dopo l'altro di fronte ai miei occhi invisibili. Alcuni sostano in piedi davanti al cancello e si scambiano sguardi stupiti o sorridono imbarazzati per i controlli minuziosi a cui li sottopongono le mani delle mie guardie prima di lasciarli entrare. C'è una donna corpulenta che attraversa il parco a passetti; l'abito lucido e nero che indossa rivela fin troppo i rotoli di carne molle del suo corpo. Con la mano davanti alla bocca bisbiglia qualcosa al suo accompagnatore, un giovane biondastro che la ascolta con l'aria fedele del cane abituato al lusso. Rilevo un primissimo piano della mano della donna, delle unghie ben curate piantate come per sbaglio su quelle mani tozze; i suoi denti ingialliti si intravedono per un istante tra le dita inanellate. Allora distolgo la telecamera da lei e la punto verso altro. Come di consueto alcune donne arrivano da sole, scendono da gradi auto scintillanti lanciando ordini agli autisti e lasciando che aprano e chiudano le portiere con gesti misurati. Tra i tanti corpi in movimento fuori dalle auto eccone uno che spicca sugli altri, una donna alta coi capelli del colore del rame incandescente che le affollano le spalle nude e la schiena. Mi soffermo su di lei, sull'abito di chiffon verde lungo fino alle caviglie, incollato al suo corpo sinuoso: delicata, senza il minimo trucco, una bellezza selvaggia capace di far scomparire le altre. Ne cerco un primo piano: pelle luminosa, occhi verdi, profondi, un sorriso appena percepibile che le sguscia via dalle labbra mentre osserva i miei agenti al lavoro, la punta del naso che si curva in alto appena. Gli occhi le guizzano a scatti leggeri quando riprende a camminare dopo i controlli. Con una delle telecamere la seguo salire la scala dell'ingresso e prelievo il profilo di uno dei suoi seni oltre l'orlo della scollatura, un attimo prima che capelli e spalle me la nascondano e riempiano il campo del video. Altri ospiti arrivano, passano i controlli, entrano nel parco. Si fermano davanti alle gabbie prima di avvicinarsi alla villa. Gli uccelli insonnoliti si muovono pigramente e sono le scimmie a concentrare gli interessi di tutti. Tutti guardano le scimmie, indicano le scimmie, salutano le scimmie agitando le mani aperte, ridendo e divertendosi ai movimenti grotteschi e meccanici degli animali, alle loro grida rauche. Le scimmie ricambiano gli sguardi con occhi curiosi. D'improvviso un pavone irritato apre la coda e la richiude di scatto piegando la cresta e rifugiandosi in un angolo della sua gabbia. Gli ospiti lo indicano con le dita. Io guardo persone e scimmie attraverso i monitor. Più tardi gli ospiti sono ormai quasi tutti nella sala del ricevimento. Non più di un'ottantina di persone, gente scelta, gli amici della marchesa, tutti sotto il mio controllo. E la festa comincia e gli schermi prendono così a collezionare per me miriadi di gesti contemporanei, movimenti che si assomigliano fin nei particolari: strette di mano, sorrisi, bocche aperte, bicchieri pieni che si vuotano, mani che scivolano su piramidi di tartine colorate, sulle geometrie di piatti e cucchiaini, su bottiglie già aperte appoggiate sui tavoli, su bicchieri riempiti che si vuotano. Come in un balletto vedo uomini e donne raggrupparsi in nuclei per conversazioni intrecciate: racchiudono in mano con eleganza bicchieri carichi di liquidi e, a piccoli intervalli, tra una parola e l'altra, li portano alle labbra e sorseggiano fissando negli occhi i loro interlocutori. Così fino a cadute di conversazione, sguardi furtivi al fasto della sala in cerca di altri a cui aggregarsi. Fino al distacco cerimonioso, un sorriso, una mano che saluta, e l'aggancio per nuovi scambi di parole. Ogni volta che gli schermi riproducono queste scene sono affascinato dalla capacità di questa gente di recitare meccanicamente tutti allo stesso modo, seguendo come automi di lusso quel copione faticosamente appreso in noiose ripetizioni di feste come questa. Rispettando le regole imposte dal loro gioco di classe si stuzzicano con occhiate discrete, risate leggere e preliminari verbali, lasciando che gli sfioramenti delle parole siano il preludio a quelli di mani e dita. Attivo i contatti audio di una delle sale e la mia cabina trabocca d'improvviso di suoni puri, un magma di frequenze fittamente intrecciate, sovrapposte con arroganza alle sonorità più limpide dei clarinetti e dei sassofoni. Spengo l'audio. Attraverso i monitor lancio occhiate anche all'esterno per controllare la situazione. Il parco attorno alla villa è quasi vuoto, c'è solo qualche coppia che cammina parlottando, o gli ultimi ritardatari impigliati nelle maglie dei controlli dei miei agenti. E mentre osservo i miei agenti al lavoro mi fa piacere costatare la loro efficienza servile. So che approfittando dei controlli indugiano le dita sulle donne, palpano le carni fingendo di cercare nascoste. Ma li lascio fare, perché la loro ottusità è pari solo alla loro volgarità, e altro non potrei aspettarmi da loro che un uso sciocco e immediato del misero potere di cui dispongono. È ormai l'ora in cui le droghe cominciano a mescolarsi all'alcool per sciogliere le menti da quelle inibizioni resistenti che ancora controllano i corpi. Piccole pipe d'hascisc e anfetamine e altre pillole colorate scivolano tra le dita e spariscono tra le bocche e denti, vedo gesti d'aspirazione e inghiottimento, sorridono e tossiscono e ridono forte, alcuni sniffano cocaina estraendola da scatoline d'argento lasciate sui tavoli tra le bottiglie vuote, tra i bicchieri rovesciati e i piatti sporchi di creme o avanzi di sandwich. I camerieri sono stati allontanati ormai, e restano solo alcuni dei miei agenti mimetizzati tra la folla per scongiurare ogni pericolo eventuale. L'orchestra continua instancabile a produrre catene di note, ora ritmi diversi da quelli un po' stereotipati e da festa che hanno preceduto questi; ora i musicisti sembrano aver trovato un'armonia finalmente; abbandonati gli spartiti hanno scoperto la loro anima, e le voci degli strumenti si sciolgono in una, diventano una voce sola e corale, impregnata di quelle sonorità notturne che miscelate alle droghe riusciranno finalmente a tirar fuori la passione dai corpi di questa gente ricca e viziata. Lo so, lo capisco da come si muovono tutti nella sala che la tensione cresce e cresce, è una corda sempre più tesa, e il punto di sfilacciamento e rottura è vicinissimo ormai. Nell'attesa esamino intanto gli altri schermi sulla parete di destra, quelli puntati sui bagni: vedo i viavai continui, le porte che si aprono e chiudono, le donne nei corridoi che aspettano impazienti il loro turno dondolandosi contro il muro e chiacchierando tra loro. Le mie lenti cercano le figure duplicate nei grandi specchi sopra ai lavandini, nei salottini lucidi di ceramiche nere stellate che precedono l'ingresso ai bagni veri e propri. Catturo riflessi elettronici di donne che si passano rossetti forti sulle labbra, boccheggiando tre o quattro volte come pesci giganti per amalgamare il colore alla pelle. Strizzano gli occhi e poi li aprono in modo eccessivo avvicinandosi agli specchi per controllare le sbavature; intingono piumini candidi in scatolette di ciprie profumate, eccitate si sbuffano nuvolette di polvere chiara sulle guance. Gli uomini invece sembrano muoversi più pacati, controllano le loro pettinature, si assestano i capelli fuori posto con leggeri colpetti delle dita, provano compiaciuti due o tre espressioni diverse inarcando le sopracciglia o gonfiando le guance, storcendo le labbra in abbozzi di sorriso. Seguo uomini e donne fin dentro ai bagni e aspetto gli sguardi stupiti quando, chiuse le porte, subito notano le statue che la marchesa ha fatto installare sopra i water. Quelli che ancora non conoscono i gusti della marchesa in genere sorridono per le pose curiose delle statue accucciate sopra le tazze con le teste sporgenti e piegate in basso nell'atto di osservare le operazioni più private. Qualcuno è indeciso: ecco un uomo che si avvicina ai due corpi nudi di ceramica rosa e quasi dimenticando la ragione che l'ha spinto dentro tocca le spalle lucide e le teste delle statue; scruta con attenzione i visi e gli occhi azzurri, gli sguardi di pietra fin troppo umani e penetranti. Poi ride come gli altri, e come gli altri si sbottona i pantaloni senza sospettare delle telecamere installate come pietre preziose dietro a quegli occhi. Non sa che quegli occhi ora sono anche i miei occhi. Sposto ancora lo sguardo dalle attività dell'uomo a quelle negli schermi puntati sulla sala della festa. Ora c'è un sassofonista che si alza in piedi e smette di suonare e scivola tra i tavoli col sassofono che gli dondola al collo; lo seguo mentre si aggancia ad una bottiglia mezza vuota e beve a lunghe sorsate con la testa buttata all'indietro. Punto una seconda telecamera su di lui, sui suoi capelli scomposti e la fronte sudata; un rivolo di vino gli cola dal mento sulla camicia sbottonata e aperta, sul petto. Continua a bere attaccato alla bottiglia fino a svuotarla e allora si ferma a fissare il nulla davanti a sé con la bottiglia in mano. Sullo schermo, per secondi, resta la sua faccia gigante: le rughe a ventaglio ai lati dei suoi occhi socchiusi, la curva forte del suo naso, la cicatrice che gli contorna il labbro inferiore. Poi si muove e io lo seguo con l'altra telecamera, riesco a mantenermi su di lui quando si sposta ancora, mi regala un campo medio controluce, infila tra le labbra il bocchino del sassofono, prova quasi sottovoce due sequenze di note contrappuntate all'orchestra, in dialogo con uno dei clarinetti, poi gonfia le guance e soffia più forte, escono suoni puri, una melodia perfetta che pare racchiudere l'essenza più profonda della notte. E infatti, quasi intuendo questa sua voglia di urlare la notte coi suoni, subito molti sono attratti da lui, lo circondano e lo nascondono, ma lui riappare oltre il cerchio di teste, è sbilanciato, lontano dall'orchestra, suona con gli occhi chiusi, e le labbra strette attorno al bocchino sembrano sorridere. La folla lo avvolge, sono su di lui e battono le mani ballando disordinati in cerchio attorno ai suoi suoni, dimentichi ormai dei gesti composti di minuti indietro. C'è come una pulsazione crescente, uno slittamento dei comportamenti verso aggressività sempre meno celate, le ansie e desideri che prendono forma con l'accumularsi dei minuti e il moltiplicarsi dei contatti tra i corpi. Inizia finalmente l'ora di splendore che le mie fedeli pupille elettroniche registreranno per me. Ora i miei monitor diventano finestre affacciate su un mondo di sogni, su quei frammenti proibiti della vita che al mattino saranno già nascosti, negati, dimenticati. Sembra che sia la sala stessa a generare questo rombo di tuono carico di grida gonfiate dagli stupefacenti, di risate troppo acute; è un ribollire di sguardi eccitati, le mani prendono sempre più a strusciare e toccare e a indugiare sui contatti. Sento l'aura di desiderio trasmettersi dalla sala attraverso i video e fin dentro la mia tana segreta e invadermi il corpo, e allora comincio a premere i pulsanti che controllano gli zoom delle telecamere e quelli delle loro rotazioni, li muovo avanti e indietro al ritmo dei movimenti dei corpi immersi nelle danze, avanti e indietro, avanti e indietro, gli equilibri sono rotti finalmente! Sulla fila dei teleschermi in basso è un continuo succedersi di facce e occhi e braccia e gambe, i movimenti tesi verso la costruzione del piacere; avanti e indietro, mani, dita, i primi vestiti inutili che volano scomposti nella sala, lanciati in aria o appoggiati sui mobili, sulle sedie, abbandonati a terra. Ecco finalmente il premio per il mio lavoro, la gioia segreta del guardiano, ecco la festa per i miei occhi, il pullulare di immagini e suoni, la danza di uomini e donne mentre scivolano verso la fase della bestia, lo sfogo ormai irreversibile dell'animale liberato in cammino verso la carne! Mi riprendo, lancio occhiate anche alle immagini dell'esterno. Il parco è deserto: solo pochi inconsapevoli dell'inizio del gioco ancora vagano chiacchierando per i viali vuoti con un bicchiere in mano. Più lontano c'è un uomo solo vicino alle gabbie, la giacca del frac ripiegata su un braccio, che spia i salti delle scimmie, il chiocciare dei pavoni, le mosse stupide degli animali prigionieri. Ma subito mi distraggo da lui, perché uno degli schermi in alto rivela i gesti di una coppia seminascosta da un cespuglio. Per un momento spengo l'audio della sala, zoomo sulla coppia e aumento al massimo il volume dei microfoni nascosti in quella zona del parco. Ansimano, sbuffano, la donna sospira con grida lente di piacere, smette, riprende. Oltre le foglie vedo una mano dell'uomo frugarle la carne, un capezzolo scompare sotto le sue dita, un seno strizzato, la mano di lei sguscia in basso tra le gambe dell'uomo, poi riprende ad ansimare quando anche l'uomo infila le dita dentro la gonna. Si muovono, rotolano per terra, spariscono dietro al cespuglio; vedo solo strati di pelle nuda, un fascio di capelli biondi intrecciati ai rami, la massa scura del corpo dell'uomo che schiaccia la donna contro il terreno. Sto per tornare ancora alle immagini della sala della festa, ma sono di colpo attirato da una scia verde che si agita in uno degli schermi puntati sui bagni. È la donna bellissima, quella dai capelli di rame che già prima nel parco aveva attratto la mia attenzione. La festa può attendere ancora per qualche istante; la seguo, si muove molto disinvolta, con passo veloce, la osservo oltrepassare la stanza di ceramiche stellate, aprire la porta di uno dei bagni, entrare e richiudersi la porta alle spalle. Come gli altri prende subito a osservare le statue e sfiorarle con le dita. Ma non sembra sorpresa, non sorride. Afferro in primo piano porzioni giganti del suo viso, il rame riccio dei suoi capelli, il collo lungo che svanisce nella scollatura del vestito, le labbra luccicanti, gli occhi verdeggianti. Colgo il movimento della sua mano sulla pelle dura degli occhi delle statue, i miei occhi. Un suo dito mi nasconde la luce, poi riappare il suo viso nel monitor, e di nuovo il dito che rabbuia l'immagine. Ma non mi piace, insiste troppo vicino agli occhi come se sapesse cosa cercare; e infatti si accanisce sulla pietra trasparente, la gratta tentando di sfilarla, la sua unghia riempie lo schermo fin quando l'inevitabile accade e il vetro dell'occhio si stacca rivelando l'obiettivo della telecamera. La vedo rimanere immobile col frammento di vetro in mano a guardare la lente del mio occhio elettronico per parecchi secondi; fa una smorfia fastidiosa, piega le labbra e inarca le sopracciglia. I suoi occhi fissano i miei indifesi. Poi incastra di nuovo la pietra nell'occhio della statua ed esce sbattendo la porta e sullo schermo rimane l'immagine delle piastrelle di ceramica nera e stellata. Preoccupato, infastidito, fisso le statue nude. Fisso la parete nuda e lucida. Poi inseguo la donna con le altre telecamere: ansioso la studio mentre risale le scale e torna nella sala. Coi diversi pulsanti cerco di mantenere l'immagine su di lei, ma la frenesia di braccia e di teste e di corpi nudi in movimenti rapidi me la confonde e presto i suoi ricci di rame si mescolano ad altri ricci e altre teste, altri capelli e altri corpi. La intravedo per secondi vicino ad una colonna della sala: è di fronte alla marchesa, le sta parlando. La marchesa è ancora vestita, annuisce. Si sorridono. Si lasciano. Cosa le avrà detto? Non è facile capire, non è possibile da qui. Ma mi distraggo anche da questo perché di colpo molti schermi emanano un lampo nero e trasmettono il buio piombato nella sala. Istintivamente attivo le telecamere all'infrarosso e subito mi investono di nuovo le sagome scure di corpi ammassati, abbracciati stretti, che danzano o in procinto di baciarsi e spogliarsi; attivo anche l'audio e sono raggiunto dalle grida di stupore euforico che seguono la notte improvvisa; il fragore acuto dei sassofoni continua sul tum-tum ritmato della batteria e sulla dolcezza liquida dei clarinetti e della tromba lanciati assieme in una musica calda e densa e ossessiva e ormai sovrabbondante di note aggiunte e alterate dalle voci sovrapposte e da cori disordinati dei più ubriachi. Resto a guardare e sentire tutto questo senza muovermi; so che ormai non c'è più ritorno, la festa è come una cosa viva, un organismo inarrestabile che avanza indipendente dalla volontà dei singoli. Rimango a pensare alla donna, ai suoi gesti così precisi, così decisi. Devo sapere cosa sa. Devo provvedere. Per minuti lunghissimi trattengo lo sguardo sugli schermi senza vedere le immagini che racchiudono, senza capirle. Penso al da farsi. Poi finalmente mi decido. Mi alzo, prendo una Polaroid da uno scaffale, prendo qualche caricatore. Esco dalla mia sala segreta, esco dalla sala dei controlli ufficiali e vado verso il parco. Minuti dopo sono di nuovo nella villa. Quando entro nella sala della festa c'è un'aria elettrica tutt'attorno, diffonde odori di cibi e sudore, i profumi dei corpi, l'esalazione della tensione sessuale, le grida, le risate, i sospiri, le parole pronunciate sottovoce, la musica. Qua e là, come lucciole, si spostano piccole luci di candela o d'accendini; alcune sfavillano per attimi attorno al braccio che le sorregge, altre appoggiate sui tavoli creano una danza di ombre, mostrano profili di corpi nudi, la carne. Per un po' mi muovo a tentoni facendomi largo tra le persone accalcate e cercando i ricci rossi della donna, ma non riesco a vederla, tutti mi spingono e urlano vicino a me, sospirano, ridono, qualcuno mi afferra le spalle e mi gira e mi stringe e mi nasconde gli occhi con i capelli. Una mano mi scivola dentro la camicia, penetra sotto la stoffa e mi accarezza il petto, ma subito quel contatto dolce mi è strappato via dalle mani di altri corpi vicini e la donna, o forse l'uomo intento su di me si allontana. Dovrei cercare la donna dai capelli rossi, ma il desiderio mi prende come fosse musica e si accavalla alla musica, mi confonde, mi si insinua dentro e mi scioglie. E ancora mi sento afferrato, ora è una donna, ne ho la certezza toccandola, sentendo il suo corpo seminudo che si struscia contro di me. Le sue labbra alcoliche si appoggiano sulle mie, la lingua mi apre un varco tra i denti e mi accarezza il palato e non riesco a liberarmi delle sue mani che mi lambiscono, della sua pelle profumata, dei suoi baci. La tocco anch'io, la carezzo, la afferro, con le dita le serro le spalle, la schiena, le natiche, le sue cosce. Attorno c'è un'esplosione di contatti, una liberazione di frequenze celate a lungo nelle viscere dei nostri cervelli che di colpo trovano l'unità. Come un coro. Così, nel buio, ci abbandoniamo tutti al fascino dell'ignoto, alle trame del caso. Più tardi la tensione si allenta; come dopo la calma che segue il lancio e il tonfo di una pietra sulla superficie d'acqua di un lago, quando l'acqua si gonfia improvvisa, poi si increspa e si stende, le onde concentriche che si nascondono in un nuovo piano liquido. Molti, stanchi ormai, liberati dall'ansia dell'orgasmo, si sono sdraiati sui divanetti lungo le pareti, o siedono scomposti sulle sedie trovate a fatica nell'oscurità. Alcuni accendini accesi e qualche candela spezzano ancora l'oscurità con bolle luminose; si odono le parole farfugliate da chi è in cerca dei vestiti, arrivano dall'ombra i sospiri di chi non è ancora sazio di sesso, o risa ovattate dalle porte che guidano nelle altre stanze. Mi rivesto con calma osservando i corpi lucidi di sudore dei miei compagni più vicini mentre si muovono pigri nella notte; vedo i loro capelli arruffati nelle lotte erotiche, le fasciature di muscoli, le curve dolci di un seno o di un ventre, negli occhi l'opacità dell'abbandono al torpore dopo il pasto di piacere. Ma di colpo la sala si riempie di grida acute, quelle di una donna forse, ma potrebbero anche essere quelle rauche di un animale, e poi si sentono ancora altre grida intrecciate, grida di dolore che spaventano. E subito è un succedersi di voci; nessuno capisce cosa sta accadendo, qualcuno urla di fare qualcosa, di accendere le luci, di accendere in fretta, e tutto attorno è una confusione di suoni. Poi finalmente le luci inondano la sala improvvise come un'esplosione; c'è un boato di sorpresa, anche di vergogna forse, comunque la luce indirizza i nostri occhi verso l'angolo dal quale provengono le grida, una zona vicino all'ingresso della sala. Lì c'è una donna in piedi, nuda, la bocca spalancata, che grida con le braccia in movimento frenetico sopra la testa, e c'è il corpo scatenato di una scimmia avvinghiato su di lei. L'animale sembra impazzito: si muove a scatti rapidi, con le braccia serrate al collo della donna, e le gambe attorcigliate come serpenti attorno al seno e alla vita. Per istanti lunghissimi restiamo tutti impietriti ad osservare la scena, totalmente presi dalle movenze di quella lotta tra i due corpi nudi, dal colore carico del sangue che fiotta da una ferita sul braccio della donna e le si spalma addosso mentre la scimmia con le sue dita nere le strappa ciuffi di capelli e continua ad accanirsi attorno al seno di lei, e al collo e alla testa, vicinissima agli occhi. Le urla delle due creature ormai spiccano chiare nel più assoluto silenzio. Guardiamo: spaventati, desiderosi di fare qualcosa; ma nessuno si muove. È come se qualcosa ci bloccasse dentro, forse è la paura, o la stanchezza per il lungo abbandono ai piaceri della carne; o forse a bloccarci è quel senso di meraviglia per la tragica bellezza di quel ballo tra donna e animale, per le sonorità cristalline del dolore che escono dalle loro bocche spalancate. Rimango immobile; è inutile buttarsi in quella mischia corpo a corpo con una scimmia. E poi ci sono le mie guardie, prima o poi interverranno, è questione di istanti ne sono certo, hanno solo bisogno del tempo necessario ad adattare i loro cervelli a questa forma di pericolo non contemplata. E infatti quasi subito quattro dei miei uomini, anche loro coi vestiti scomposti, si lanciano sulla donna che urla, afferrano la scimmia per le braccia e le gambe e cominciano a tirarla per allontanarla dalla donna. Ma la donna e la bestia, sbilanciate, cadono a terra mentre sono ancora avvinghiate e si rotolano sui tappeti tra sangue e singhiozzi, e altri secondi passano prima che i miei uomini possano buttarsi su loro per cercare di immobilizzare la scimmia. Lascio agli altri il piacere della vista della cattura. Scivolo fuori dal cerchio di persone ammassate attorno alla zona di lotta, lancio rapide occhiate alle teste, ai nasi, alle bocche, agli occhi, ai capelli bruni, a quelli rossi e biondi, quelli neri, quelli rossi e ricci di nuovo. Mi sposto da una zona all'altra della folla, e finalmente mi fermo dietro a un gruppetto compatto di persone. Sorrido soddisfatto. Ancora mi guardo attorno; una volta certo di passare inosservato, mi sposto indietro verso i tavoli, verso i piatti sporchi, verso le posate, le forchette, i coltelli. Ne afferro uno. Poi mi avvicino ancora alle spalle della folla che guarda. Dopo un po' la situazione è sotto controllo: la lotta è finita e la scimmia è a terra, morta, e io sono soddisfatto dell'esito del mio lavoro. Però non posso dire altrettanto del lavoro dei miei uomini. Dovrò punirli per quello che sono stati capaci di fare davanti agli ospiti. La marchesa sarà sicuramente dura con me per questo e loro pagheranno per la loro stupidità. Potevano evitare il sangue, l'orrore. Invece quando la scimmia ha cominciato a mordere i due uomini che cercavano di immobilizzarla, un altro dei miei agenti, quello più stupido e incapace di ricordare le regole, catturato dal suo istinto più selvaggio, ha afferrato una bottiglia da terra e ha preso a scagliare colpi in testa alla scimmia, colpi forti, precisi, ripetuti, e ha continuato anche quando la bottiglia si è spaccata e un fiotto di sangue è schizzato fuori dal cranio a pezzi della scimmia, ha continuato fin quando la scimmia ha smesso di divincolarsi e di urlare e si è semplicemente afflosciata per terra incapace ormai di fare male, di muoversi, un corpo morto con la testa spalancata e tutto quel sangue attorno come una corona rossa di capelli. Adesso mi fa quasi pena a guardarla così per terra, ormai sparita. Era solo un povero animale impazzito. Mi fa pena ora a vederla così massacrata. Li punirò per questo spettacolo. Sì, li punirò, anche se in fondo tutto questo non ha molta importanza per me. So come trattare con la marchesa; so come tenerla in pugno. I miei occhietti segreti servono pure a qualcosa. La marchesa non è un problema. È il resto ad avere veramente importanza. E il resto, il mio lavoro di stasera, quello è stato perfetto. Finita la lotta, ora sono tutti sulla donna ferita a cercare di rialzarla e aiutarla, e c'è un chiasso di persone che parlano insieme, tutti che vogliono sapere, tutti a chiederle cosa è successo, domandarle di cosa ha bisogno e mille altre parole intrecciate che riaccendono la tensione proprio nel momento in cui l'eccitazione per la serata sembrava ormai alle spalle. Un uomo si accosta alla donna con una coperta tra le mani; gliela appoggia addosso. Lei rimane a terra in ginocchio, immobile in mezzo alle persone, senza ascoltare, senza rispondere. Sposta la testa, allunga le dita verso la stoffa. I capelli arruffati e sporchi di sangue le pendono come erbe stoppose sulla fronte; fa guizzare a scatti gli occhi spalancati, a sinistra, in alto, a sinistra, poi a destra di colpo. Come dopo una lotta con sciami di fantasmi. Poi si struscia ossessiva un dito sulla ferita al braccio, sfrega lo squarcio insanguinato come a scacciare via del pelo rimasto della scimmia. L'uomo che l'ha avvolta nella coperta la fa rialzare e la sostiene con un braccio mentre con l'altro si apre un varco verso l'uscita tra la gente incuriosita. Una volta che i due sono oltre la porta, subito l'interesse generale scivola dalla donna alla scimmia a terra, con una cresta bianco-rossa di sangue e cervello che le spunta dallo spacco nel cranio e si allarga sul tappeto; le braccia e le gambe troppo lunghe, contorte negli spasimi della morte. Vedo qualcuno approfittare della confusione per rivestirsi in fretta con gesti appena imbarazzati; nessuno sembra badare a me ora, un poco in disparte dal gruppo, indietro, vicino ai tavoli, mentre sorrido e mi diverto a giocare coi coltelli sporchi di panna. Lancio lunghe occhiate tra le teste e i corpi, tra i vestiti aperti e i capelli fuori posto e le guance arrossate. Ben presto però anche l'interesse per l'animale si esaurisce. C'è un allentamento della tensione magica accumulata tra noi, le persone rompono il cerchio stretto attorno alla scimmia e gli spazi tra noi si allargano con moto centrifugo. Il flusso di bisbigli e borbottii si sbriciola pian piano, le voci tornano a farsi più chiare e a pronunciare parole. Ma io continuo a guardarmi in giro e a sorridere perché so che la serata ci riserva altre sorprese e così sono in attesa del nuovo picco di tensione. E quasi a incarnare i miei pensieri, ecco un grido che parte da qualcuno come lo scatto di un fascio di muscoli e condensa di colpo e ancora l'attenzione di ciascuno. Ansiosi, confusi, in un istante siamo tutti rivolti verso una donna in piedi vicina all'angolo che col dito ci indica qualcosa dietro a un divano. Bene, finalmente è il momento. Corriamo verso il divano, e spingendo e parlando e urlando assieme ci raccogliamo di nuovo a semicerchio davanti a un corpo accasciato sul tappeto, il corpo di una donna che il gioco indifferente del caso ha composto in una posizione che duplica quella della scimmia: anche lei è supina, anche in lei un braccio e le gambe sono divaricate; e anche lei, come la scimmia, ha la testa fasciata dal rosso, una corona fulva di capelli; e poi c'è anche l'altro rosso, quello del sangue, un rivolo che scivola giù da oltre il braccio contorto sulla schiena e oltre la mano serrata sul manico di un coltello infilato tra le scapole, appena sopra l'orlo del vestito di chiffon verde. Allora finalmente entro in azione. «Nessuno si muova!» grido rivolto al gruppo. «Servizio di sicurezza! Nessuno si muova!» urlo. Le parole congelano l'aria e d'improvviso il silenzio è perfetto. A un mio gesto, i miei uomini schizzano veloci verso le porte per impedire a chiunque di uscire. Lancio occhiate alle facce curiose che ho di fronte, colgo alcuni sguardi spaventati, occhi troppo spalancati, bocche aperte e distorte da pensieri cupi di paura. Ma ci sono anche quelli che sembrano più calmi, lontani, quasi a voler ostentare la loro estraneità all'assassinio. E poi mentre li scruto, mi cade lo sguardo su una faccia seminascosta da altre teste, un uomo in seconda fila: le guance pallide, gli occhi piccoli e troppo accostati al naso e un paio di baffetti fastidiosi che gli scendono ai lati della bocca, e le labbra sottili che quasi sogghignano, e i capelli neri e lucidi e stranamente troppo a posto, pettinati di lato. È quello che prima dell'inizio della festa guardava solitario le scimmie e i pavoni. Sì, è lui. Resto a lungo a fissarlo e l'uomo sente il mio occhio su di lui e si china in avanti quasi per nascondersi, ma sbaglia posizione e così riesco a vedergli la cravatta perfettamente annodata al collo, e la camicia abbottonata e il frac ancora infilato. Per una decina di secondi studio questa sua aria compita, e tutto in lui sembra suggerirmi l'idea che, unico tra noi, si sia astenuto dai divertimenti erotici. Allora so che lui è la persona giusta; e ha anche la mia statura. Sì, lui è la persona che mi serve. Gli sorrido con freddezza. Poi mi volto via da lui, mi avvicino al cadavere e mi chino. È un corpo sinuoso: le cosce affusolate e bianche, le natiche di carne compatta fasciate di chiffon lucido, le scapole che escono dall'orlo del vestito come piccole ali. E tra le scapole il coltello, la sua mano, il polso, un braccialetto d'oro, un rivolo di sangue. Le sfioro il polso con le dita. Non c'è battito. Allora mi alzo e dalla tasca estraggo la Polaroid, poi giro attorno al corpo e scatto quattro foto da diverse angolazioni. Il flash lampeggia. Odo il vociare stupido di alcune donne vicine che seguono attente i miei movimenti. Continuo a scattare foto prima di spostarla. Per me, per la polizia che verrà e vorrà sapere. Un primo piano della mano serrata attorno al coltello, le unghie sporche di sangue secco, l'impugnatura d'argento della lama, le cosce aperte, le caviglie. Dopo ogni scatto sfilo la foto dall'apparecchio, aspetto qualche secondo, separo lo strato di sviluppo dalla carta. Guardo l'immagine, la appoggio a terra e riprendo a scattare. Dopo un po' le foto si sono accumulate sul tappeto. Allora sfilo la mano della donna dal coltello, poi impugno il manico con un fazzoletto e tiro strappandole il coltello dalla schiena. Viene via dalla carne ancora calda con facilità, con uno fruscio appena percettibile, come fosse piantato in un blocco di burro morbido. È un normale coltello da cucina, affilato, uguale a quello che anch'io avevo impugnato pochi minuti prima. Lo trattengo in mano, mi alzo, mostro la lama insanguinata alle persone davanti. «È stato qualcuno di voi!» dico con durezza. Appoggio coltello e fazzoletto su un tavolo. «Il coltello è uno di quelli usati per i rinfreschi prima dei vostri giochetti!» Subito vedo la marchesa sgusciare fuori dal gruppo «Ehi!» dice avvicinandosi; mi guarda con aria arcigna, le dita aperte di una mano puntate contro di me. «Come si permette di parlare in questo modo? Lei è soltanto un...» «Silenzio!» le urlo. «Non è il momento per questo. È stata uccisa una donna, ed è stato qualcuno di loro a farlo. Le proteste a dopo. Ora non è il momento...» La marchesa prova a balbettare qualcosa, però non aggiunge altre parole, certamente sorpresa dal mio tono. Ma le mie telecamere sono una ragione sufficiente a zittire anche lei. E lei lo sa. La sicurezza ha un suo prezzo. Così restiamo in silenzio. Allora mi avvicino agli ospiti, scruto tutti quelli della prima fila, uno dopo l'altro, fissandoli negli occhi per accrescere la loro ansia, per inculcare in loro l'idea che li sospetti tutti. «È stato uno di voi» dico. «Ma vi assicuro che non riuscirà a scamparla.» Guardo con disprezzo l'uomo coi baffetti in seconda fila, e lui subito distoglie lo sguardo da me, e il suo sogghigno di poco fa è ormai soltanto una smorfia. Bene; quale colpevole più perfetto di lui potrebbe esserci? «Ci sono delle telecamere installate nella sala» dico. «Telecamere all'infrarosso. Possono filmare anche al buio.» Faccio una pausa e il silenzio riempie la stanza. Non un gesto, un movimento, un sussurro. «Non ne uscirete puliti. È tutto filmato. Tutto. È meglio che chi ha ammazzato la donna si faccia avanti...» Aspetto che le mie parole raggiungano le loro menti. Subito sale un borbottio, ciascuno muove attorno gli occhi in cerca degli occhi del vicino, stupidamente sperando che almeno uno nel gruppo si faccia avanti sul serio e confessi il delitto e liberi gli altri dal peso del sospetto. Imbecilli! Ma nessuno si muove. Nella sala cade ancora un silenzio freddo, lungo. «Bene» dico. «Come volete...» Con un cenno chiamo uno dei miei uomini. «Perquisiteli uno a uno. Prendete nomi, dati, indirizzi, amicizie, gusti particolari di ciascuno...» Faccio una pausa. «Senza eccezioni» aggiungo lanciando un'occhiata insolente alla marchesa. Poi torno alla donna assassinata; la muovo, la giro prima che sia la polizia a farlo. Le braccia molli seguono il movimento rotatorio del corpo. Guardo i suoi capelli rosso fuoco. Il viso è contratto in una smorfia e racchiude l'immagine del dolore dei suoi ultimi attimi di vita. Gli occhi verdi, intensi, sono spalancati, e anche la bocca è spalancata, pronta a gridare. La sua bellezza selvaggia è finita. Sparita. Peccato. Prendo ancora la macchina fotografica, inserisco un nuovo caricatore e comincio a scattare altre foto: la donna distesa sul tappeto, a mezzo busto, il profilo dei suoi seni, il volto, gli occhi, il suo naso curvato verso l'alto, le labbra, i denti lucidi. Poi un polso, un neo sotto l'oro del braccialetto, la mano insanguinata, le dita, le unghie. Le cosce, le caviglie, i piedi. Le sfioro un capezzolo che esce dallo squarcio nel vestito; sotto l'aureola bruna si scorgono dei graffi, sicuramente prodotti durante la lotta con l'assassino. Sono l'unico che si muove. Giro attorno al corpo, mi alzo, mi abbasso, mi inginocchio. Ogni tanto guardo furtivo quelli che mi stanno a guardare, mi rialzo. Il flash accende la stanza con bagliori bianchi, disegna dappertutto ombre di pochi attimi. Alla fine osservo le foto cercando indizi, quei particolari minimi che nella realtà sfuggono all'occhio e che potrebbero invece apparire in immagini come queste sfrondate da un contesto fuorviante e inutile. Cerco tracce, segni, informazioni che potrebbero rivelarmi l'identità dell'assassino. Ma non c'è nulla. Per la polizia saranno perfette: nessuno avrà da protestare; nessuno troverà nulla. Allora ripongo in tasca le foto. «Potete cominciare» dico brusco ai miei uomini. «Io vado a dare un'occhiata ai filmati.» I miei uomini si muovono, vengono in avanti, si distribuiscono tra i presenti. «Non ne uscirete puliti!» dico. Li osservo tutti di sfuggita. Sorrido asciutto sul borbottio di voci che segue le mie parole. Quando sono vicino alla stanza video mi prende un senso forte di soddisfazione per gli sviluppi imprevisti della serata: le mani mi tremano, le dita fremono. Una volta dentro do un'occhiata svogliata ai pochi monitor collegati a quelle telecamere la cui presenza è nota anche alla marchesa. Poi compongo col telecomando la combinazione per l'apertura che accede alla mia stanza segreta, quella che nasconde gli schermi delle altre telecamere, le mie. Scivolo oltre il pannello scorrevole, lo richiudo. Mi assesto nella sedia girevole circondato dagli schermi accesi e riempio occhi e cervello con le immagini. Con un piede imprimo un moto rotatorio alla sedia, schermi e schermi mi sfilano davanti, aumento la spinta e giro e giro schiacciato contro lo schienale, e la realtà piatta è di colpo una composizione di sequenze sovrapposte, le figure diventano scie di luce e macchie di colore che guizzano: teste e occhi, braccia, mani, dita, corpi, bocche, le piante nel parco, i musi grotteschi delle scimmie nella gabbia, lo sfavillio confuso dei lampadari nelle sale, i getti verso l'alto dell'acqua nelle fontane, la polvere d'acqua che scende, ancora teste e occhi, corpi, braccia, un tavolo, le mani, i movimenti, gli spostamenti, le frazioni di spazio occupate e abbandonate da porzioni di corpi, o da oggetti o luci, i giochi di chiari e scuri, le ombre allungate, i bordi luccicanti, le scie saettanti. Ogni persona, cosa, oggetto insegue ogni altro. Tutto diventa simultaneo. La rotazione amalgama, comprime e fonde. Quando mi freno la testa mi gira. Negli otto schermi centrali vedo i miei agenti continuare con solerzia i loro controlli inutili. Proseguono infaticabili con le loro domande; fedeli agli ordini riempiono le pagine dei loro taccuini con nomi, date, fatti. Informazioni di nessuna importanza. Torno nella stanza di controllo delle telecamere ufficialmente note. Arresto un videoregistratore collegato ad una delle telecamere nel parco. Prendo il nastro e rientro nel mio covo segreto. Infilo il nastro in un videoregistratore, lo riavvolgo e poi attivo la funzione di riproduzione. Subito in uno schermo appaiono le immagini della gabbia con le scimmie. Faccio scorrere il nastro in avanti mantenendo le immagini sul video. Alcuni ospiti arrivano da sinistra, si fermano, guardano gli animali; poi schizzano a destra e fuori dallo schermo. Passano davanti alla gabbia come scie di colore. Poi ne arrivano altri; si fermano, se ne vanno. Poi altri ancora. La scena si ripete uguale fin quasi nei particolari; cambia solo il numero degli ospiti e i loro gesti che la velocità riduce a frammenti insignificanti di gesti. Di nuovo e di nuovo fin quando tutti gli ospiti sono ormai dentro la villa e la gabbia rimane l'unico elemento sullo schermo. Allora riavvolgo il nastro e le persone arrancano all'indietro velocemente con passetti meccanici. Poi altre persone. E altre ancora, e altre, fin quando finalmente scorgo ciò che sto cercando e blocco il nastro e lo rimando in avanti a velocità normale. Ecco l'uomo con i baffetti e il sorriso idiota. Lo vedo camminare dietro ad un gruppetto di ospiti. Gli ospiti si fermano, l'uomo si ferma. Come tutti anche loro guardano le scimmie per alcuni secondi, poi il gruppetto si allontana e l'uomo rimane da solo per alcuni altri istanti prima di andarsene anche lui. Fermo l'immagine, controllo il contagiri. Riavvolgo tutto il nastro e da uno degli scaffali prendo un nuovo nastro; lo infilo in un altro videoregistratore, poi inizio a copiare il nastro già inciso nel nastro nuovo. In breve ho finito il montaggio. Nella copia ho spostato la sequenza in cui appare l'uomo coi baffetti. Ora l'uomo è uno degli ultimi ad arrivare, uno degli ultimi ad osservare le scimmie. Ho anche allungato il tempo di sosta dell'uomo davanti alle gabbie bloccando l'immagine nel nastro originale e continuando a copiarla nel secondo nastro. Poi ho tagliato via minuti di immagini inutili che descrivevano i movimenti lenti delle scimmie in gabbia, accorciando così i tempi tra l'uscita dell'uomo dallo schermo e la nuova sequenza interessante. Riavvolgo il nastro e lo riproduco ancora una volta cercandovi eventuali tracce che mostrino l'operazione di montaggio: l'uomo coi baffetti sosta a lungo davanti alla gabbia, poi se ne va e la gabbia e le scimmie rimangono padrone dello schermo per un po'. Pochi minuti più tardi la luce che illumina le gabbie salta d'improvviso, e nella penombra prodotta dalle altre luci del parco si intravede una figura in frac proveniente dalla stessa direzione da cui l'uomo coi baffetti se n'era andato. Si vede la figura avanzare furtiva verso la gabbia, armeggiare con la serratura, aprire la porta di metallo, afferrare una scimmia e richiudere la gabbia e allontanarsi verso la sala della festa con la scimmia stretta tra le braccia. Poi la gabbia e le scimmie riempiono di nuovo lo schermo per altri minuti. Blocco il nastro. Mentre lo riavvolgo fisso soddisfatto la matrice di monitor davanti a me. Il montaggio mi sembra perfetto, il contenuto semplice, evidente: le modifiche accentuano l'interesse dell'uomo per la gabbia delle scimmie; la sua sosta troppo lunga spicca per contrasto con quella di pochi secondi degli altri; la sua figura in frac crea relazioni lampanti con la figura dell'uomo irriconoscibile che apre le gabbie e trascina la scimmia tra la folla per creare un diversivo e compiere così più facilmente il delitto. Come non pensare ad un legame stretto tra i due? Come non immaginare che l'uomo coi baffetti e l'assassino siano la stessa persona? Mai a nessuno verrebbe in mente di pensare di associare la figura misteriosa al capo dei Servizi di Sicurezza. Di pensare che ho falsificato i nastri. Che ragione avrei di farlo? Io sono il capo dei Servizi di Sicurezza; io sono l'addetto al controllo. Perché dovrei mancare al mio dovere? Che ragione avrei per alterare le immagini? I fatti sono documentati, ci sono i filmati; la realtà che presento è certa. Innegabile. Ci sono le immagini. Ci sono le telecamere, testimoni fedeli. Le immagini non mentono. Mai. Sfilo il nastro dal videoregistratore. Apro la porta, me la chiudo bene alle spalle ed esco anche dalla seconda stanza dei video. Torno verso la sala della festa. La polizia è già arrivata, l'ho visto dai monitor, e sicuramente saranno contenti quando sapranno del nastro; vogliono sempre buone prove loro, e questa volta non saranno delusi. E già me li vedo a dirmi che è stato un bene che ci fossi io a controllare, e che col nastro scopriranno subito l'assassino. Sono sicuro che me lo diranno. E ci sono anche gli altri nastri, gli dirò io molto soddisfatto, c'è una stanza di controllo e ci sono altri nastri, e due telecamere sono a infrarosso, e io non li ho ancora controllati, ma sono sicuro che esaminando quei nastri lo troverete l'assassino. Certo. Sono sicuro. Certo, mi diranno loro, e prenderanno i nastri e li guarderanno, e guardandoli si accorgeranno del tipo coi baffetti vicino alla gabbia delle scimmie, e così qualche guaio glielo farò passare. Le sue beghe e i suoi intrallazzi verranno fuori. Sicuramente ci sono, tutti abbiamo sempre qualcosa da nascondere, sicuramente anche lui i suoi peccatucci li avrà. Ma le immagini di questo nastro sono pulite e avrò tutta la notte per vedere e pulire i film delle altre telecamere, così non scopriranno nulla di certo. A operazione finita del volto dell'assassino non ci saranno tracce. Forse se ne vedrà il corpo, un corpo molto simile a quello dell'uomo coi baffetti, e forse si vedrà anche quel corpo mentre infila la lama nella schiena della vittima. Ma il volto no, quello purtroppo non si riuscirà mai a vederlo, perché la qualità delle immagini all'infrarosso non sarà perfetta, perché la confusione di corpi coprirà spesso gli spostamenti dell'assassino, perché l'assassino, quasi conoscesse la posizione delle telecamere, non si avvicinerà mai troppo alle telecamere, non rivolgerà mai la testa in modo da poter essere riconosciuto. Così gli indizi potranno soltanto favorire i sospetti: l'uomo, la gabbia, le scimmie, la gabbia aperta, la scimmia scappata, un diversivo per compiere il delitto, perché è stato così a lungo davanti alla gabbia, dov'era durante la festa, perché è l'unico che ha ancora la camicia allacciata, e la cravatta? Dov'era? Che faceva? L'ha vista qualcuno? Chi ha aperto la gabbia? Le solite storie. Perché, perché, perché? Chi? Le solite cose. Ma non riusciranno ad avere prove. Solo il sospetto. Ma anche il sospetto mi basta. Qualche guaio lo passerà anche lui. E quando non troveranno prove sarà il turno degli altri. Dov'era, cosa faceva, con chi? Perché? Perché? Lo domanderanno a tutti questi idioti mascherati da persone. E perché non ci sono impronte sul coltello? E dov'era quando ha sentito gridare? Ha visto niente o nessuno che possa aiutarci a identificare l'assassino? Conosceva la vittima? E anche la marchesa passerà qualche guaio per aver organizzato una festa come questa. La polizia sapeva e chiudeva gli occhi e intascava qualcosa, pochi spiccioli elargiti dalla marchesa, ma sufficienti a comperare il silenzio. Ma adesso, con un omicidio sulle spalle, come si fa a tacere, a far finta di non sapere? Eppure non scopriranno nulla: caso insoluto, assassino introvabile, caso archiviato. Assassino sconosciuto nonostante l'efficienza dei sistemi di sicurezza. Nonostante la presenza delle telecamere. Ma con chi se la possono prendere? Con me? coi miei uomini? Con le telecamere? O con l'assassino che ha fatto in modo di non farsi riconoscere durante l'omicidio? Percorro i corridoi, le stanze. Esco nel prato che circonda la villa. Passo davanti alla gabbia delle scimmie poi arrivo vicino alla piscina. Ignara, seduta sul bordo coi piedi a bagno c'è Virna, la figlia della marchesa. Come sempre distante da quanto le accade attorno, fa ciò che l'ho sempre vista fare da quando lavoro qui, la sola cosa che sembra capace di fare: leggere. Leggere senza capire. Anche a quest'ora, anche con tutto quello che succede in casa sua e davanti a lei. Mi accosto. Mi vede, distoglie gli occhi dal libro e mi sorride e mostra i suoi denti bianchi e il suo sguardo lontano. Agita i piedi nell'acqua. Le sfilo il libro dalle mani; è un libro di poesie, Le effemeridi della luna nera del poeta russo Eisenkievich. Scuoto la testa. Anche Virna scuote la testa. Sorride. Mi riprende il libro dalle mani. I suoi piedi creano onde concentriche nell'acqua. Torno a camminare verso la sala della festa col nastro in mano. «Dovresti stare meno appiccicato a quelle stupide telecamere!» mi grida dietro Virna. «Faresti meglio a leggere questo!» dice indicando il libro. Ride adesso. È allegra. A modo suo attraente, forse proprio per la distanza che riesce a mettere tra lei e le cose del mondo. Mi giro verso di lei e le sorrido anch'io, ma non le dico niente. |
 |
| Scende la sera e da qui, oltre i vetri della finestra, oltre il muro di cinta della villa, vedo nuvole basse, lunghe, colorate di rosso. Tra non molto arriveranno gli ospiti. Le mie guardie si muovono già nel parco con i gesti consueti; girano lente tra le siepi, attorno alla casa, in silenzio; fedeli agli ordini impartiti cercano improbabili intrusi, sorvegliano le entrate. Anch’io voglio verificare che tutto sia a posto; entro nella stanza di controllo e accendo i monitor allineati lungo le pareti in triplice fila; la stanza si riempie di bagliori bianchi, di righe orizzontali che scorrono lente dal basso in alto, di zig-zag disordinati sugli schermi. Sfioro con le dita le file di pulsanti nel pannello di comando, infilo le cassette nei videoregistratori, li accendo, attivo le telecamere una dopo l’altra. Ruotando sulla sedia girevole lancio rapide occhiate alle immagini del parco vuoto, alla piscina illuminata, alla scalinata esterna che conduce fino all’atrio centrale, a due o tre sale sfavillanti di luci, al salone della festa coi tavoli traboccanti di cibi, all’angolo riservato ai musicisti con i leggii già disposti di fronte alle sedie. Su uno degli schermi colgo un movimento, è la scia colorata di un corpo che esce dal campo di uno dei monitor. Subito ruoto la telecamera corrispondente a destra fin quando il giardiniere si staglia controluce al centro del quadro; lo vedo camminare verso la centralina di comando delle fontane, aziona le pompe per gli zampilli e abbassa l’interruttore che controlla le luci del parco. Si allontana. Dietro di lui scorgo i profili dei pini, le strutture intricate dei castagni, i bordi smussati delle siepi. Gli schermi mi rimandano quadri spezzati della villa; ogni cespuglio nel parco, ogni angolo della casa si specchia negli occhi attenti delle mie telecamere, e la villa è come frammentata e moltiplicata davanti a me in miriadi di ville diverse, immagini che trattengo e registro catturando sezioni di spazio sfrondate dal contesto inutile che le circonda. Gli animali nelle gabbie sembrano tranquilli: dormono. Solo una delle scimmie si sveglia d’improvviso al fruscio dell’acqua proiettata in alto. Gira la testa verso il cerchio irregolare che l’acqua in cascata compone nella vasca della fontana più vicina alle gabbie e si gratta la pancia a caccia di qualche pulce fastidiosa. Una guardia si accosta ora alle gabbie, rimane a scrutare gli animali per qualche secondo, poi scuote mollemente la testa prima di riprendere il giro, e mi fa sorridere questo suo gesto di superiorità nei confronti degli animali; le mie telecamere stanno a lui come i suoi occhi stanno alle scimmie; osserva le scimmie con disprezzo senza sapere che è lui, a sua volta, ad essere scimmia per me. A volte mi chiedo quali sarebbero le reazioni dei miei uomini se riuscissero a intuire la verità: che il loro appartenere ai servizi di sicurezza è illusione, un involucro ufficiale opportuno solo a mascherare la mia attività. Ma so che è un pensiero inutile il mio; la loro ottusità già li condanna: non riuscirebbero mai a capire, e quindi non riusciranno mai a sapere. Ciò che veramente conta, il mio lavoro segreto, non li riguarda. Sanno che il controllo è il problema essenziale, e sanno anche che essendo io il capo dei Servizi di Sicurezza devo avere ogni cosa sotto controllo. Questo lo sanno, questo è normale. Ma come controllare, come usare gli strumenti di controllo, perché decidere di guardare, questo non riguarda loro né nessun altro. Il fascino che scaturisce dall’osservazione, quello non potrebbero mai apprezzarlo. Osservare, controllare, proteggere, proteggere tutto come in una cassaforte. Gli oggetti, le persone. Tutto. Osservare le persone come gioielli rari, pietre preziose cariche di movimento proprio e di vita, studiare i loro sguardi, le sequenze interessanti di gesti e parole, i comportamenti pubblici e quelli privati, sgusciare dentro le loro intimità e svelarle come si estrae il corpo lucido di un’ostrica dal suo guscio spalancato. Osservare tutto. Osservare. Capire. E usare le immagini, quando è il caso di farlo. Come in un gioco. Osservarli. Come animali in gabbia, appunto. Lancio un’ultima occhiata ai monitor; tutto è in perfetto ordine. Naturalmente. I primi ad arrivare sono i musicisti. Tutta gente accuratamente selezionata dalla marchesa stessa. Gli uomini indossano vestiti scuri, cravatte nere; le donne sfilano con lunghi abiti da sera scollati che scoprono spalle e lembi di pelle. Con gli astucci degli strumenti in mano ciondolano lenti davanti al cancello, si osservano attorno cauti, forse appena a disagio per il fasto inconsueto che li circonda. Così mi diverto a inseguirli con due o tre telecamere nascoste tra gli alberi, colgo qualche primo piano delle loro espressioni di meraviglia, il muoversi a scatti di qualche testa, un ciuffo biondo di capelli che scivola sulla fronte di una delle donne, il riflesso di una luce in una scarpa di vernice nera, un bagliore bianco. Li seguo mentre avanzano con movimento quasi continuo dagli schermi di sinistra via via a quelli di destra, dall’alto progressivamente in basso man mano che procedono verso l’interno del parco e verso la villa. Mentre uno dei camerieri li accompagna verso il settore della sala riservato ai musicisti, anche gli altri ospiti cominciano ad arrivare e sfilano l’uno dopo l’altro di fronte ai miei occhi invisibili. Alcuni sostano in piedi davanti al cancello e si scambiano sguardi stupiti o sorridono imbarazzati per i controlli minuziosi a cui li sottopongono le mani delle mie guardie prima di lasciarli entrare. C’è una donna corpulenta che attraversa il parco a passetti; l’abito lucido e nero che indossa rivela fin troppo i rotoli di carne molle del suo corpo. Con la mano davanti alla bocca bisbiglia qualcosa al suo accompagnatore, un giovane biondastro che la ascolta con l’aria fedele del cane abituato al lusso. Rilevo un primissimo piano della mano della donna, delle unghie ben curate piantate come per sbaglio su quelle mani tozze; i suoi denti ingialliti si intravedono per un istante tra le dita inanellate. Allora distolgo la telecamera da lei e la punto verso altro. Come di consueto alcune donne arrivano da sole, scendono da gradi auto scintillanti lanciando ordini agli autisti e lasciando che aprano e chiudano le portiere con gesti misurati. Tra i tanti corpi in movimento fuori dalle auto eccone uno che spicca sugli altri, una donna alta coi capelli del colore del rame incandescente che le affollano le spalle nude e la schiena. Mi soffermo su di lei, sull’abito di chiffon verde lungo fino alle caviglie, incollato al suo corpo sinuoso: delicata, senza il minimo trucco, una bellezza selvaggia capace di far scomparire le altre. Ne cerco un primo piano: pelle luminosa, occhi verdi, profondi, un sorriso appena percepibile che le sguscia via dalle labbra mentre osserva i miei agenti al lavoro, la punta del naso che si curva in alto appena. Gli occhi le guizzano a scatti leggeri quando riprende a camminare dopo i controlli. Con una delle telecamere la seguo salire la scala dell’ingresso e prelievo il profilo di uno dei suoi seni oltre l’orlo della scollatura, un attimo prima che capelli e spalle me la nascondano e riempiano il campo del video. Altri ospiti arrivano, passano i controlli, entrano nel parco. Si fermano davanti alle gabbie prima di avvicinarsi alla villa. Gli uccelli insonnoliti si muovono pigramente e sono le scimmie a concentrare gli interessi di tutti. Tutti guardano le scimmie, indicano le scimmie, salutano le scimmie agitando le mani aperte, ridendo e divertendosi ai movimenti grotteschi e meccanici degli animali, alle loro grida rauche. Le scimmie ricambiano gli sguardi con occhi curiosi. D’improvviso un pavone irritato apre la coda e la richiude di scatto piegando la cresta e rifugiandosi in un angolo della sua gabbia. Gli ospiti lo indicano con le dita. Io guardo persone e scimmie attraverso i monitor. Più tardi gli ospiti sono ormai quasi tutti nella sala del ricevimento. Non più di un’ottantina di persone, gente scelta, gli amici della marchesa, tutti sotto il mio controllo. E la festa comincia e gli schermi prendono così a collezionare per me miriadi di gesti contemporanei, movimenti che si assomigliano fin nei particolari: strette di mano, sorrisi, bocche aperte, bicchieri pieni che si vuotano, mani che scivolano su piramidi di tartine colorate, sulle geometrie di piatti e cucchiaini, su bottiglie già aperte appoggiate sui tavoli, su bicchieri riempiti che si vuotano. Come in un balletto vedo uomini e donne raggrupparsi in nuclei per conversazioni intrecciate: racchiudono in mano con eleganza bicchieri carichi di liquidi e, a piccoli intervalli, tra una parola e l’altra, li portano alle labbra e sorseggiano fissando negli occhi i loro interlocutori. Così fino a cadute di conversazione, sguardi furtivi al fasto della sala in cerca di altri a cui aggregarsi. Fino al distacco cerimonioso, un sorriso, una mano che saluta, e l’aggancio per nuovi scambi di parole. Ogni volta che gli schermi riproducono queste scene sono affascinato dalla capacità di questa gente di recitare meccanicamente tutti allo stesso modo, seguendo come automi di lusso quel copione faticosamente appreso in noiose ripetizioni di feste come questa. Rispettando le regole imposte dal loro gioco di classe si stuzzicano con occhiate discrete, risate leggere e preliminari verbali, lasciando che gli sfioramenti delle parole siano il preludio a quelli di mani e dita. Attivo i contatti audio di una delle sale e la mia cabina trabocca d’improvviso di suoni puri, un magma di frequenze fittamente intrecciate, sovrapposte con arroganza alle sonorità più limpide dei clarinetti e dei sassofoni. Spengo l’audio. Attraverso i monitor lancio occhiate anche all’esterno per controllare la situazione. Il parco attorno alla villa è quasi vuoto, c’è solo qualche coppia che cammina parlottando, o gli ultimi ritardatari impigliati nelle maglie dei controlli dei miei agenti. E mentre osservo i miei agenti al lavoro mi fa piacere costatare la loro efficienza servile. So che approfittando dei controlli indugiano le dita sulle donne, palpano le carni fingendo di cercare nascoste. Ma li lascio fare, perché la loro ottusità è pari solo alla loro volgarità, e altro non potrei aspettarmi da loro che un uso sciocco e immediato del misero potere di cui dispongono. È ormai l’ora in cui le droghe cominciano a mescolarsi all’alcool per sciogliere le menti da quelle inibizioni resistenti che ancora controllano i corpi. Piccole pipe d’hascisc e anfetamine e altre pillole colorate scivolano tra le dita e spariscono tra le bocche e denti, vedo gesti d’aspirazione e inghiottimento, sorridono e tossiscono e ridono forte, alcuni sniffano cocaina estraendola da scatoline d’argento lasciate sui tavoli tra le bottiglie vuote, tra i bicchieri rovesciati e i piatti sporchi di creme o avanzi di sandwich. I camerieri sono stati allontanati ormai, e restano solo alcuni dei miei agenti mimetizzati tra la folla per scongiurare ogni pericolo eventuale. L’orchestra continua instancabile a produrre catene di note, ora ritmi diversi da quelli un po’ stereotipati e da festa che hanno preceduto questi; ora i musicisti sembrano aver trovato un’armonia finalmente; abbandonati gli spartiti hanno scoperto la loro anima, e le voci degli strumenti si sciolgono in una, diventano una voce sola e corale, impregnata di quelle sonorità notturne che miscelate alle droghe riusciranno finalmente a tirar fuori la passione dai corpi di questa gente ricca e viziata. Lo so, lo capisco da come si muovono tutti nella sala che la tensione cresce e cresce, è una corda sempre più tesa, e il punto di sfilacciamento e rottura è vicinissimo ormai. Nell’attesa esamino intanto gli altri schermi sulla parete di destra, quelli puntati sui bagni: vedo i viavai continui, le porte che si aprono e chiudono, le donne nei corridoi che aspettano impazienti il loro turno dondolandosi contro il muro e chiacchierando tra loro. Le mie lenti cercano le figure duplicate nei grandi specchi sopra ai lavandini, nei salottini lucidi di ceramiche nere stellate che precedono l’ingresso ai bagni veri e propri. Catturo riflessi elettronici di donne che si passano rossetti forti sulle labbra, boccheggiando tre o quattro volte come pesci giganti per amalgamare il colore alla pelle. Strizzano gli occhi e poi li aprono in modo eccessivo avvicinandosi agli specchi per controllare le sbavature; intingono piumini candidi in scatolette di ciprie profumate, eccitate si sbuffano nuvolette di polvere chiara sulle guance. Gli uomini invece sembrano muoversi più pacati, controllano le loro pettinature, si assestano i capelli fuori posto con leggeri colpetti delle dita, provano compiaciuti due o tre espressioni diverse inarcando le sopracciglia o gonfiando le guance, storcendo le labbra in abbozzi di sorriso. Seguo uomini e donne fin dentro ai bagni e aspetto gli sguardi stupiti quando, chiuse le porte, subito notano le statue che la marchesa ha fatto installare sopra i water. Quelli che ancora non conoscono i gusti della marchesa in genere sorridono per le pose curiose delle statue accucciate sopra le tazze con le teste sporgenti e piegate in basso nell’atto di osservare le operazioni più private. Qualcuno è indeciso: ecco un uomo che si avvicina ai due corpi nudi di ceramica rosa e quasi dimenticando la ragione che l’ha spinto dentro tocca le spalle lucide e le teste delle statue; scruta con attenzione i visi e gli occhi azzurri, gli sguardi di pietra fin troppo umani e penetranti. Poi ride come gli altri, e come gli altri si sbottona i pantaloni senza sospettare delle telecamere installate come pietre preziose dietro a quegli occhi. Non sa che quegli occhi ora sono anche i miei occhi. Sposto ancora lo sguardo dalle attività dell’uomo a quelle negli schermi puntati sulla sala della festa. Ora c’è un sassofonista che si alza in piedi e smette di suonare e scivola tra i tavoli col sassofono che gli dondola al collo; lo seguo mentre si aggancia ad una bottiglia mezza vuota e beve a lunghe sorsate con la testa buttata all’indietro. Punto una seconda telecamera su di lui, sui suoi capelli scomposti e la fronte sudata; un rivolo di vino gli cola dal mento sulla camicia sbottonata e aperta, sul petto. Continua a bere attaccato alla bottiglia fino a svuotarla e allora si ferma a fissare il nulla davanti a sé con la bottiglia in mano. Sullo schermo, per secondi, resta la sua faccia gigante: le rughe a ventaglio ai lati dei suoi occhi socchiusi, la curva forte del suo naso, la cicatrice che gli contorna il labbro inferiore. Poi si muove e io lo seguo con l’altra telecamera, riesco a mantenermi su di lui quando si sposta ancora, mi regala un campo medio controluce, infila tra le labbra il bocchino del sassofono, prova quasi sottovoce due sequenze di note contrappuntate all’orchestra, in dialogo con uno dei clarinetti, poi gonfia le guance e soffia più forte, escono suoni puri, una melodia perfetta che pare racchiudere l’essenza più profonda della notte. E infatti, quasi intuendo questa sua voglia di urlare la notte coi suoni, subito molti sono attratti da lui, lo circondano e lo nascondono, ma lui riappare oltre il cerchio di teste, è sbilanciato, lontano dall’orchestra, suona con gli occhi chiusi, e le labbra strette attorno al bocchino sembrano sorridere. La folla lo avvolge, sono su di lui e battono le mani ballando disordinati in cerchio attorno ai suoi suoni, dimentichi ormai dei gesti composti di minuti indietro. C’è come una pulsazione crescente, uno slittamento dei comportamenti verso aggressività sempre meno celate, le ansie e desideri che prendono forma con l’accumularsi dei minuti e il moltiplicarsi dei contatti tra i corpi. Inizia finalmente l’ora di splendore che le mie fedeli pupille elettroniche registreranno per me. Ora i miei monitor diventano finestre affacciate su un mondo di sogni, su quei frammenti proibiti della vita che al mattino saranno già nascosti, negati, dimenticati. Sembra che sia la sala stessa a generare questo rombo di tuono carico di grida gonfiate dagli stupefacenti, di risate troppo acute; è un ribollire di sguardi eccitati, le mani prendono sempre più a strusciare e toccare e a indugiare sui contatti. Sento l’aura di desiderio trasmettersi dalla sala attraverso i video e fin dentro la mia tana segreta e invadermi il corpo, e allora comincio a premere i pulsanti che controllano gli zoom delle telecamere e quelli delle loro rotazioni, li muovo avanti e indietro al ritmo dei movimenti dei corpi immersi nelle danze, avanti e indietro, avanti e indietro, gli equilibri sono rotti finalmente! Sulla fila dei teleschermi in basso è un continuo succedersi di facce e occhi e braccia e gambe, i movimenti tesi verso la costruzione del piacere; avanti e indietro, mani, dita, i primi vestiti inutili che volano scomposti nella sala, lanciati in aria o appoggiati sui mobili, sulle sedie, abbandonati a terra. Ecco finalmente il premio per il mio lavoro, la gioia segreta del guardiano, ecco la festa per i miei occhi, il pullulare di immagini e suoni, la danza di uomini e donne mentre scivolano verso la fase della bestia, lo sfogo ormai irreversibile dell’animale liberato in cammino verso la carne! Mi riprendo, lancio occhiate anche alle immagini dell’esterno. Il parco è deserto: solo pochi inconsapevoli dell’inizio del gioco ancora vagano chiacchierando per i viali vuoti con un bicchiere in mano. Più lontano c’è un uomo solo vicino alle gabbie, la giacca del frac ripiegata su un braccio, che spia i salti delle scimmie, il chiocciare dei pavoni, le mosse stupide degli animali prigionieri. Ma subito mi distraggo da lui, perché uno degli schermi in alto rivela i gesti di una coppia seminascosta da un cespuglio. Per un momento spengo l’audio della sala, zoomo sulla coppia e aumento al massimo il volume dei microfoni nascosti in quella zona del parco. Ansimano, sbuffano, la donna sospira con grida lente di piacere, smette, riprende. Oltre le foglie vedo una mano dell’uomo frugarle la carne, un capezzolo scompare sotto le sue dita, un seno strizzato, la mano di lei sguscia in basso tra le gambe dell’uomo, poi riprende ad ansimare quando anche l’uomo infila le dita dentro la gonna. Si muovono, rotolano per terra, spariscono dietro al cespuglio; vedo solo strati di pelle nuda, un fascio di capelli biondi intrecciati ai rami, la massa scura del corpo dell’uomo che schiaccia la donna contro il terreno. Sto per tornare ancora alle immagini della sala della festa, ma sono di colpo attirato da una scia verde che si agita in uno degli schermi puntati sui bagni. È la donna bellissima, quella dai capelli di rame che già prima nel parco aveva attratto la mia attenzione. La festa può attendere ancora per qualche istante; la seguo, si muove molto disinvolta, con passo veloce, la osservo oltrepassare la stanza di ceramiche stellate, aprire la porta di uno dei bagni, entrare e richiudersi la porta alle spalle. Come gli altri prende subito a osservare le statue e sfiorarle con le dita. Ma non sembra sorpresa, non sorride. Afferro in primo piano porzioni giganti del suo viso, il rame riccio dei suoi capelli, il collo lungo che svanisce nella scollatura del vestito, le labbra luccicanti, gli occhi verdeggianti. Colgo il movimento della sua mano sulla pelle dura degli occhi delle statue, i miei occhi. Un suo dito mi nasconde la luce, poi riappare il suo viso nel monitor, e di nuovo il dito che rabbuia l’immagine. Ma non mi piace, insiste troppo vicino agli occhi come se sapesse cosa cercare; e infatti si accanisce sulla pietra trasparente, la gratta tentando di sfilarla, la sua unghia riempie lo schermo fin quando l’inevitabile accade e il vetro dell’occhio si stacca rivelando l’obiettivo della telecamera. La vedo rimanere immobile col frammento di vetro in mano a guardare la lente del mio occhio elettronico per parecchi secondi; fa una smorfia fastidiosa, piega le labbra e inarca le sopracciglia. I suoi occhi fissano i miei indifesi. Poi incastra di nuovo la pietra nell’occhio della statua ed esce sbattendo la porta e sullo schermo rimane l’immagine delle piastrelle di ceramica nera e stellata. Preoccupato, infastidito, fisso le statue nude. Fisso la parete nuda e lucida. Poi inseguo la donna con le altre telecamere: ansioso la studio mentre risale le scale e torna nella sala. Coi diversi pulsanti cerco di mantenere l’immagine su di lei, ma la frenesia di braccia e di teste e di corpi nudi in movimenti rapidi me la confonde e presto i suoi ricci di rame si mescolano ad altri ricci e altre teste, altri capelli e altri corpi. La intravedo per secondi vicino ad una colonna della sala: è di fronte alla marchesa, le sta parlando. La marchesa è ancora vestita, annuisce. Si sorridono. Si lasciano. Cosa le avrà detto? Non è facile capire, non è possibile da qui. Ma mi distraggo anche da questo perché di colpo molti schermi emanano un lampo nero e trasmettono il buio piombato nella sala. Istintivamente attivo le telecamere all’infrarosso e subito mi investono di nuovo le sagome scure di corpi ammassati, abbracciati stretti, che danzano o in procinto di baciarsi e spogliarsi; attivo anche l’audio e sono raggiunto dalle grida di stupore euforico che seguono la notte improvvisa; il fragore acuto dei sassofoni continua sul tum-tum ritmato della batteria e sulla dolcezza liquida dei clarinetti e della tromba lanciati assieme in una musica calda e densa e ossessiva e ormai sovrabbondante di note aggiunte e alterate dalle voci sovrapposte e da cori disordinati dei più ubriachi. Resto a guardare e sentire tutto questo senza muovermi; so che ormai non c’è più ritorno, la festa è come una cosa viva, un organismo inarrestabile che avanza indipendente dalla volontà dei singoli. Rimango a pensare alla donna, ai suoi gesti così precisi, così decisi. Devo sapere cosa sa. Devo provvedere. Per minuti lunghissimi trattengo lo sguardo sugli schermi senza vedere le immagini che racchiudono, senza capirle. Penso al da farsi. Poi finalmente mi decido. Mi alzo, prendo una Polaroid da uno scaffale, prendo qualche caricatore. Esco dalla mia sala segreta, esco dalla sala dei controlli ufficiali e vado verso il parco. Minuti dopo sono di nuovo nella villa. Quando entro nella sala della festa c’è un’aria elettrica tutt’attorno, diffonde odori di cibi e sudore, i profumi dei corpi, l’esalazione della tensione sessuale, le grida, le risate, i sospiri, le parole pronunciate sottovoce, la musica. Qua e là, come lucciole, si spostano piccole luci di candela o d’accendini; alcune sfavillano per attimi attorno al braccio che le sorregge, altre appoggiate sui tavoli creano una danza di ombre, mostrano profili di corpi nudi, la carne. Per un po’ mi muovo a tentoni facendomi largo tra le persone accalcate e cercando i ricci rossi della donna, ma non riesco a vederla, tutti mi spingono e urlano vicino a me, sospirano, ridono, qualcuno mi afferra le spalle e mi gira e mi stringe e mi nasconde gli occhi con i capelli. Una mano mi scivola dentro la camicia, penetra sotto la stoffa e mi accarezza il petto, ma subito quel contatto dolce mi è strappato via dalle mani di altri corpi vicini e la donna, o forse l’uomo intento su di me si allontana. Dovrei cercare la donna dai capelli rossi, ma il desiderio mi prende come fosse musica e si accavalla alla musica, mi confonde, mi si insinua dentro e mi scioglie. E ancora mi sento afferrato, ora è una donna, ne ho la certezza toccandola, sentendo il suo corpo seminudo che si struscia contro di me. Le sue labbra alcoliche si appoggiano sulle mie, la lingua mi apre un varco tra i denti e mi accarezza il palato e non riesco a liberarmi delle sue mani che mi lambiscono, della sua pelle profumata, dei suoi baci. La tocco anch’io, la carezzo, la afferro, con le dita le serro le spalle, la schiena, le natiche, le sue cosce. Attorno c’è un’esplosione di contatti, una liberazione di frequenze celate a lungo nelle viscere dei nostri cervelli che di colpo trovano l’unità. Come un coro. Così, nel buio, ci abbandoniamo tutti al fascino dell’ignoto, alle trame del caso. Più tardi la tensione si allenta; come dopo la calma che segue il lancio e il tonfo di una pietra sulla superficie d’acqua di un lago, quando l’acqua si gonfia improvvisa, poi si increspa e si stende, le onde concentriche che si nascondono in un nuovo piano liquido. Molti, stanchi ormai, liberati dall’ansia dell’orgasmo, si sono sdraiati sui divanetti lungo le pareti, o siedono scomposti sulle sedie trovate a fatica nell’oscurità. Alcuni accendini accesi e qualche candela spezzano ancora l’oscurità con bolle luminose; si odono le parole farfugliate da chi è in cerca dei vestiti, arrivano dall’ombra i sospiri di chi non è ancora sazio di sesso, o risa ovattate dalle porte che guidano nelle altre stanze. Mi rivesto con calma osservando i corpi lucidi di sudore dei miei compagni più vicini mentre si muovono pigri nella notte; vedo i loro capelli arruffati nelle lotte erotiche, le fasciature di muscoli, le curve dolci di un seno o di un ventre, negli occhi l’opacità dell’abbandono al torpore dopo il pasto di piacere. Ma di colpo la sala si riempie di grida acute, quelle di una donna forse, ma potrebbero anche essere quelle rauche di un animale, e poi si sentono ancora altre grida intrecciate, grida di dolore che spaventano. E subito è un succedersi di voci; nessuno capisce cosa sta accadendo, qualcuno urla di fare qualcosa, di accendere le luci, di accendere in fretta, e tutto attorno è una confusione di suoni. Poi finalmente le luci inondano la sala improvvise come un’esplosione; c’è un boato di sorpresa, anche di vergogna forse, comunque la luce indirizza i nostri occhi verso l’angolo dal quale provengono le grida, una zona vicino all’ingresso della sala. Lì c’è una donna in piedi, nuda, la bocca spalancata, che grida con le braccia in movimento frenetico sopra la testa, e c’è il corpo scatenato di una scimmia avvinghiato su di lei. L’animale sembra impazzito: si muove a scatti rapidi, con le braccia serrate al collo della donna, e le gambe attorcigliate come serpenti attorno al seno e alla vita. Per istanti lunghissimi restiamo tutti impietriti ad osservare la scena, totalmente presi dalle movenze di quella lotta tra i due corpi nudi, dal colore carico del sangue che fiotta da una ferita sul braccio della donna e le si spalma addosso mentre la scimmia con le sue dita nere le strappa ciuffi di capelli e continua ad accanirsi attorno al seno di lei, e al collo e alla testa, vicinissima agli occhi. Le urla delle due creature ormai spiccano chiare nel più assoluto silenzio. Guardiamo: spaventati, desiderosi di fare qualcosa; ma nessuno si muove. È come se qualcosa ci bloccasse dentro, forse è la paura, o la stanchezza per il lungo abbandono ai piaceri della carne; o forse a bloccarci è quel senso di meraviglia per la tragica bellezza di quel ballo tra donna e animale, per le sonorità cristalline del dolore che escono dalle loro bocche spalancate. Rimango immobile; è inutile buttarsi in quella mischia corpo a corpo con una scimmia. E poi ci sono le mie guardie, prima o poi interverranno, è questione di istanti ne sono certo, hanno solo bisogno del tempo necessario ad adattare i loro cervelli a questa forma di pericolo non contemplata. E infatti quasi subito quattro dei miei uomini, anche loro coi vestiti scomposti, si lanciano sulla donna che urla, afferrano la scimmia per le braccia e le gambe e cominciano a tirarla per allontanarla dalla donna. Ma la donna e la bestia, sbilanciate, cadono a terra mentre sono ancora avvinghiate e si rotolano sui tappeti tra sangue e singhiozzi, e altri secondi passano prima che i miei uomini possano buttarsi su loro per cercare di immobilizzare la scimmia. Lascio agli altri il piacere della vista della cattura. Scivolo fuori dal cerchio di persone ammassate attorno alla zona di lotta, lancio rapide occhiate alle teste, ai nasi, alle bocche, agli occhi, ai capelli bruni, a quelli rossi e biondi, quelli neri, quelli rossi e ricci di nuovo. Mi sposto da una zona all’altra della folla, e finalmente mi fermo dietro a un gruppetto compatto di persone. Sorrido soddisfatto. Ancora mi guardo attorno; una volta certo di passare inosservato, mi sposto indietro verso i tavoli, verso i piatti sporchi, verso le posate, le forchette, i coltelli. Ne afferro uno. Poi mi avvicino ancora alle spalle della folla che guarda. Dopo un po’ la situazione è sotto controllo: la lotta è finita e la scimmia è a terra, morta, e io sono soddisfatto dell’esito del mio lavoro. Però non posso dire altrettanto del lavoro dei miei uomini. Dovrò punirli per quello che sono stati capaci di fare davanti agli ospiti. La marchesa sarà sicuramente dura con me per questo e loro pagheranno per la loro stupidità. Potevano evitare il sangue, l’orrore. Invece quando la scimmia ha cominciato a mordere i due uomini che cercavano di immobilizzarla, un altro dei miei agenti, quello più stupido e incapace di ricordare le regole, catturato dal suo istinto più selvaggio, ha afferrato una bottiglia da terra e ha preso a scagliare colpi in testa alla scimmia, colpi forti, precisi, ripetuti, e ha continuato anche quando la bottiglia si è spaccata e un fiotto di sangue è schizzato fuori dal cranio a pezzi della scimmia, ha continuato fin quando la scimmia ha smesso di divincolarsi e di urlare e si è semplicemente afflosciata per terra incapace ormai di fare male, di muoversi, un corpo morto con la testa spalancata e tutto quel sangue attorno come una corona rossa di capelli. Adesso mi fa quasi pena a guardarla così per terra, ormai sparita. Era solo un povero animale impazzito. Mi fa pena ora a vederla così massacrata. Li punirò per questo spettacolo. Sì, li punirò, anche se in fondo tutto questo non ha molta importanza per me. So come trattare con la marchesa; so come tenerla in pugno. I miei occhietti segreti servono pure a qualcosa. La marchesa non è un problema. È il resto ad avere veramente importanza. E il resto, il mio lavoro di stasera, quello è stato perfetto. Finita la lotta, ora sono tutti sulla donna ferita a cercare di rialzarla e aiutarla, e c’è un chiasso di persone che parlano insieme, tutti che vogliono sapere, tutti a chiederle cosa è successo, domandarle di cosa ha bisogno e mille altre parole intrecciate che riaccendono la tensione proprio nel momento in cui l’eccitazione per la serata sembrava ormai alle spalle. Un uomo si accosta alla donna con una coperta tra le mani; gliela appoggia addosso. Lei rimane a terra in ginocchio, immobile in mezzo alle persone, senza ascoltare, senza rispondere. Sposta la testa, allunga le dita verso la stoffa. I capelli arruffati e sporchi di sangue le pendono come erbe stoppose sulla fronte; fa guizzare a scatti gli occhi spalancati, a sinistra, in alto, a sinistra, poi a destra di colpo. Come dopo una lotta con sciami di fantasmi. Poi si struscia ossessiva un dito sulla ferita al braccio, sfrega lo squarcio insanguinato come a scacciare via del pelo rimasto della scimmia. L’uomo che l’ha avvolta nella coperta la fa rialzare e la sostiene con un braccio mentre con l’altro si apre un varco verso l’uscita tra la gente incuriosita. Una volta che i due sono oltre la porta, subito l’interesse generale scivola dalla donna alla scimmia a terra, con una cresta bianco-rossa di sangue e cervello che le spunta dallo spacco nel cranio e si allarga sul tappeto; le braccia e le gambe troppo lunghe, contorte negli spasimi della morte. Vedo qualcuno approfittare della confusione per rivestirsi in fretta con gesti appena imbarazzati; nessuno sembra badare a me ora, un poco in disparte dal gruppo, indietro, vicino ai tavoli, mentre sorrido e mi diverto a giocare coi coltelli sporchi di panna. Lancio lunghe occhiate tra le teste e i corpi, tra i vestiti aperti e i capelli fuori posto e le guance arrossate. Ben presto però anche l’interesse per l’animale si esaurisce. C’è un allentamento della tensione magica accumulata tra noi, le persone rompono il cerchio stretto attorno alla scimmia e gli spazi tra noi si allargano con moto centrifugo. Il flusso di bisbigli e borbottii si sbriciola pian piano, le voci tornano a farsi più chiare e a pronunciare parole. Ma io continuo a guardarmi in giro e a sorridere perché so che la serata ci riserva altre sorprese e così sono in attesa del nuovo picco di tensione. E quasi a incarnare i miei pensieri, ecco un grido che parte da qualcuno come lo scatto di un fascio di muscoli e condensa di colpo e ancora l’attenzione di ciascuno. Ansiosi, confusi, in un istante siamo tutti rivolti verso una donna in piedi vicina all’angolo che col dito ci indica qualcosa dietro a un divano. Bene, finalmente è il momento. Corriamo verso il divano, e spingendo e parlando e urlando assieme ci raccogliamo di nuovo a semicerchio davanti a un corpo accasciato sul tappeto, il corpo di una donna che il gioco indifferente del caso ha composto in una posizione che duplica quella della scimmia: anche lei è supina, anche in lei un braccio e le gambe sono divaricate; e anche lei, come la scimmia, ha la testa fasciata dal rosso, una corona fulva di capelli; e poi c’è anche l’altro rosso, quello del sangue, un rivolo che scivola giù da oltre il braccio contorto sulla schiena e oltre la mano serrata sul manico di un coltello infilato tra le scapole, appena sopra l’orlo del vestito di chiffon verde. Allora finalmente entro in azione. «Nessuno si muova!» grido rivolto al gruppo. «Servizio di sicurezza! Nessuno si muova!» urlo. Le parole congelano l’aria e d’improvviso il silenzio è perfetto. A un mio gesto, i miei uomini schizzano veloci verso le porte per impedire a chiunque di uscire. Lancio occhiate alle facce curiose che ho di fronte, colgo alcuni sguardi spaventati, occhi troppo spalancati, bocche aperte e distorte da pensieri cupi di paura. Ma ci sono anche quelli che sembrano più calmi, lontani, quasi a voler ostentare la loro estraneità all’assassinio. E poi mentre li scruto, mi cade lo sguardo su una faccia seminascosta da altre teste, un uomo in seconda fila: le guance pallide, gli occhi piccoli e troppo accostati al naso e un paio di baffetti fastidiosi che gli scendono ai lati della bocca, e le labbra sottili che quasi sogghignano, e i capelli neri e lucidi e stranamente troppo a posto, pettinati di lato. È quello che prima dell’inizio della festa guardava solitario le scimmie e i pavoni. Sì, è lui. Resto a lungo a fissarlo e l’uomo sente il mio occhio su di lui e si china in avanti quasi per nascondersi, ma sbaglia posizione e così riesco a vedergli la cravatta perfettamente annodata al collo, e la camicia abbottonata e il frac ancora infilato. Per una decina di secondi studio questa sua aria compita, e tutto in lui sembra suggerirmi l’idea che, unico tra noi, si sia astenuto dai divertimenti erotici. Allora so che lui è la persona giusta; e ha anche la mia statura. Sì, lui è la persona che mi serve. Gli sorrido con freddezza. Poi mi volto via da lui, mi avvicino al cadavere e mi chino. È un corpo sinuoso: le cosce affusolate e bianche, le natiche di carne compatta fasciate di chiffon lucido, le scapole che escono dall’orlo del vestito come piccole ali. E tra le scapole il coltello, la sua mano, il polso, un braccialetto d’oro, un rivolo di sangue. Le sfioro il polso con le dita. Non c’è battito. Allora mi alzo e dalla tasca estraggo la Polaroid, poi giro attorno al corpo e scatto quattro foto da diverse angolazioni. Il flash lampeggia. Odo il vociare stupido di alcune donne vicine che seguono attente i miei movimenti. Continuo a scattare foto prima di spostarla. Per me, per la polizia che verrà e vorrà sapere. Un primo piano della mano serrata attorno al coltello, le unghie sporche di sangue secco, l’impugnatura d’argento della lama, le cosce aperte, le caviglie. Dopo ogni scatto sfilo la foto dall’apparecchio, aspetto qualche secondo, separo lo strato di sviluppo dalla carta. Guardo l’immagine, la appoggio a terra e riprendo a scattare. Dopo un po’ le foto si sono accumulate sul tappeto. Allora sfilo la mano della donna dal coltello, poi impugno il manico con un fazzoletto e tiro strappandole il coltello dalla schiena. Viene via dalla carne ancora calda con facilità, con uno fruscio appena percettibile, come fosse piantato in un blocco di burro morbido. È un normale coltello da cucina, affilato, uguale a quello che anch’io avevo impugnato pochi minuti prima. Lo trattengo in mano, mi alzo, mostro la lama insanguinata alle persone davanti. «È stato qualcuno di voi!» dico con durezza. Appoggio coltello e fazzoletto su un tavolo. «Il coltello è uno di quelli usati per i rinfreschi prima dei vostri giochetti!» Subito vedo la marchesa sgusciare fuori dal gruppo «Ehi!» dice avvicinandosi; mi guarda con aria arcigna, le dita aperte di una mano puntate contro di me. «Come si permette di parlare in questo modo? Lei è soltanto un…» «Silenzio!» le urlo. «Non è il momento per questo. È stata uccisa una donna, ed è stato qualcuno di loro a farlo. Le proteste a dopo. Ora non è il momento…» La marchesa prova a balbettare qualcosa, però non aggiunge altre parole, certamente sorpresa dal mio tono. Ma le mie telecamere sono una ragione sufficiente a zittire anche lei. E lei lo sa. La sicurezza ha un suo prezzo. Così restiamo in silenzio. Allora mi avvicino agli ospiti, scruto tutti quelli della prima fila, uno dopo l’altro, fissandoli negli occhi per accrescere la loro ansia, per inculcare in loro l’idea che li sospetti tutti. «È stato uno di voi» dico. «Ma vi assicuro che non riuscirà a scamparla.» Guardo con disprezzo l’uomo coi baffetti in seconda fila, e lui subito distoglie lo sguardo da me, e il suo sogghigno di poco fa è ormai soltanto una smorfia. Bene; quale colpevole più perfetto di lui potrebbe esserci? «Ci sono delle telecamere installate nella sala» dico. «Telecamere all’infrarosso. Possono filmare anche al buio.» Faccio una pausa e il silenzio riempie la stanza. Non un gesto, un movimento, un sussurro. «Non ne uscirete puliti. È tutto filmato. Tutto. È meglio che chi ha ammazzato la donna si faccia avanti…» Aspetto che le mie parole raggiungano le loro menti. Subito sale un borbottio, ciascuno muove attorno gli occhi in cerca degli occhi del vicino, stupidamente sperando che almeno uno nel gruppo si faccia avanti sul serio e confessi il delitto e liberi gli altri dal peso del sospetto. Imbecilli! Ma nessuno si muove. Nella sala cade ancora un silenzio freddo, lungo. «Bene» dico. «Come volete…» Con un cenno chiamo uno dei miei uomini. «Perquisiteli uno a uno. Prendete nomi, dati, indirizzi, amicizie, gusti particolari di ciascuno…» Faccio una pausa. «Senza eccezioni» aggiungo lanciando un’occhiata insolente alla marchesa. Poi torno alla donna assassinata; la muovo, la giro prima che sia la polizia a farlo. Le braccia molli seguono il movimento rotatorio del corpo. Guardo i suoi capelli rosso fuoco. Il viso è contratto in una smorfia e racchiude l’immagine del dolore dei suoi ultimi attimi di vita. Gli occhi verdi, intensi, sono spalancati, e anche la bocca è spalancata, pronta a gridare. La sua bellezza selvaggia è finita. Sparita. Peccato. Prendo ancora la macchina fotografica, inserisco un nuovo caricatore e comincio a scattare altre foto: la donna distesa sul tappeto, a mezzo busto, il profilo dei suoi seni, il volto, gli occhi, il suo naso curvato verso l’alto, le labbra, i denti lucidi. Poi un polso, un neo sotto l’oro del braccialetto, la mano insanguinata, le dita, le unghie. Le cosce, le caviglie, i piedi. Le sfioro un capezzolo che esce dallo squarcio nel vestito; sotto l’aureola bruna si scorgono dei graffi, sicuramente prodotti durante la lotta con l’assassino. Sono l’unico che si muove. Giro attorno al corpo, mi alzo, mi abbasso, mi inginocchio. Ogni tanto guardo furtivo quelli che mi stanno a guardare, mi rialzo. Il flash accende la stanza con bagliori bianchi, disegna dappertutto ombre di pochi attimi. Alla fine osservo le foto cercando indizi, quei particolari minimi che nella realtà sfuggono all’occhio e che potrebbero invece apparire in immagini come queste sfrondate da un contesto fuorviante e inutile. Cerco tracce, segni, informazioni che potrebbero rivelarmi l’identità dell’assassino. Ma non c’è nulla. Per la polizia saranno perfette: nessuno avrà da protestare; nessuno troverà nulla. Allora ripongo in tasca le foto. «Potete cominciare» dico brusco ai miei uomini. «Io vado a dare un’occhiata ai filmati.» I miei uomini si muovono, vengono in avanti, si distribuiscono tra i presenti. «Non ne uscirete puliti!» dico. Li osservo tutti di sfuggita. Sorrido asciutto sul borbottio di voci che segue le mie parole. Quando sono vicino alla stanza video mi prende un senso forte di soddisfazione per gli sviluppi imprevisti della serata: le mani mi tremano, le dita fremono. Una volta dentro do un’occhiata svogliata ai pochi monitor collegati a quelle telecamere la cui presenza è nota anche alla marchesa. Poi compongo col telecomando la combinazione per l’apertura che accede alla mia stanza segreta, quella che nasconde gli schermi delle altre telecamere, le mie. Scivolo oltre il pannello scorrevole, lo richiudo. Mi assesto nella sedia girevole circondato dagli schermi accesi e riempio occhi e cervello con le immagini. Con un piede imprimo un moto rotatorio alla sedia, schermi e schermi mi sfilano davanti, aumento la spinta e giro e giro schiacciato contro lo schienale, e la realtà piatta è di colpo una composizione di sequenze sovrapposte, le figure diventano scie di luce e macchie di colore che guizzano: teste e occhi, braccia, mani, dita, corpi, bocche, le piante nel parco, i musi grotteschi delle scimmie nella gabbia, lo sfavillio confuso dei lampadari nelle sale, i getti verso l’alto dell’acqua nelle fontane, la polvere d’acqua che scende, ancora teste e occhi, corpi, braccia, un tavolo, le mani, i movimenti, gli spostamenti, le frazioni di spazio occupate e abbandonate da porzioni di corpi, o da oggetti o luci, i giochi di chiari e scuri, le ombre allungate, i bordi luccicanti, le scie saettanti. Ogni persona, cosa, oggetto insegue ogni altro. Tutto diventa simultaneo. La rotazione amalgama, comprime e fonde. Quando mi freno la testa mi gira. Negli otto schermi centrali vedo i miei agenti continuare con solerzia i loro controlli inutili. Proseguono infaticabili con le loro domande; fedeli agli ordini riempiono le pagine dei loro taccuini con nomi, date, fatti. Informazioni di nessuna importanza. Torno nella stanza di controllo delle telecamere ufficialmente note. Arresto un videoregistratore collegato ad una delle telecamere nel parco. Prendo il nastro e rientro nel mio covo segreto. Infilo il nastro in un videoregistratore, lo riavvolgo e poi attivo la funzione di riproduzione. Subito in uno schermo appaiono le immagini della gabbia con le scimmie. Faccio scorrere il nastro in avanti mantenendo le immagini sul video. Alcuni ospiti arrivano da sinistra, si fermano, guardano gli animali; poi schizzano a destra e fuori dallo schermo. Passano davanti alla gabbia come scie di colore. Poi ne arrivano altri; si fermano, se ne vanno. Poi altri ancora. La scena si ripete uguale fin quasi nei particolari; cambia solo il numero degli ospiti e i loro gesti che la velocità riduce a frammenti insignificanti di gesti. Di nuovo e di nuovo fin quando tutti gli ospiti sono ormai dentro la villa e la gabbia rimane l’unico elemento sullo schermo. Allora riavvolgo il nastro e le persone arrancano all’indietro velocemente con passetti meccanici. Poi altre persone. E altre ancora, e altre, fin quando finalmente scorgo ciò che sto cercando e blocco il nastro e lo rimando in avanti a velocità normale. Ecco l’uomo con i baffetti e il sorriso idiota. Lo vedo camminare dietro ad un gruppetto di ospiti. Gli ospiti si fermano, l’uomo si ferma. Come tutti anche loro guardano le scimmie per alcuni secondi, poi il gruppetto si allontana e l’uomo rimane da solo per alcuni altri istanti prima di andarsene anche lui. Fermo l’immagine, controllo il contagiri. Riavvolgo tutto il nastro e da uno degli scaffali prendo un nuovo nastro; lo infilo in un altro videoregistratore, poi inizio a copiare il nastro già inciso nel nastro nuovo. In breve ho finito il montaggio. Nella copia ho spostato la sequenza in cui appare l’uomo coi baffetti. Ora l’uomo è uno degli ultimi ad arrivare, uno degli ultimi ad osservare le scimmie. Ho anche allungato il tempo di sosta dell’uomo davanti alle gabbie bloccando l’immagine nel nastro originale e continuando a copiarla nel secondo nastro. Poi ho tagliato via minuti di immagini inutili che descrivevano i movimenti lenti delle scimmie in gabbia, accorciando così i tempi tra l’uscita dell’uomo dallo schermo e la nuova sequenza interessante. Riavvolgo il nastro e lo riproduco ancora una volta cercandovi eventuali tracce che mostrino l’operazione di montaggio: l’uomo coi baffetti sosta a lungo davanti alla gabbia, poi se ne va e la gabbia e le scimmie rimangono padrone dello schermo per un po’. Pochi minuti più tardi la luce che illumina le gabbie salta d’improvviso, e nella penombra prodotta dalle altre luci del parco si intravede una figura in frac proveniente dalla stessa direzione da cui l’uomo coi baffetti se n’era andato. Si vede la figura avanzare furtiva verso la gabbia, armeggiare con la serratura, aprire la porta di metallo, afferrare una scimmia e richiudere la gabbia e allontanarsi verso la sala della festa con la scimmia stretta tra le braccia. Poi la gabbia e le scimmie riempiono di nuovo lo schermo per altri minuti. Blocco il nastro. Mentre lo riavvolgo fisso soddisfatto la matrice di monitor davanti a me. Il montaggio mi sembra perfetto, il contenuto semplice, evidente: le modifiche accentuano l’interesse dell’uomo per la gabbia delle scimmie; la sua sosta troppo lunga spicca per contrasto con quella di pochi secondi degli altri; la sua figura in frac crea relazioni lampanti con la figura dell’uomo irriconoscibile che apre le gabbie e trascina la scimmia tra la folla per creare un diversivo e compiere così più facilmente il delitto. Come non pensare ad un legame stretto tra i due? Come non immaginare che l’uomo coi baffetti e l’assassino siano la stessa persona? Mai a nessuno verrebbe in mente di pensare di associare la figura misteriosa al capo dei Servizi di Sicurezza. Di pensare che ho falsificato i nastri. Che ragione avrei di farlo? Io sono il capo dei Servizi di Sicurezza; io sono l’addetto al controllo. Perché dovrei mancare al mio dovere? Che ragione avrei per alterare le immagini? I fatti sono documentati, ci sono i filmati; la realtà che presento è certa. Innegabile. Ci sono le immagini. Ci sono le telecamere, testimoni fedeli. Le immagini non mentono. Mai. Sfilo il nastro dal videoregistratore. Apro la porta, me la chiudo bene alle spalle ed esco anche dalla seconda stanza dei video. Torno verso la sala della festa. La polizia è già arrivata, l’ho visto dai monitor, e sicuramente saranno contenti quando sapranno del nastro; vogliono sempre buone prove loro, e questa volta non saranno delusi. E già me li vedo a dirmi che è stato un bene che ci fossi io a controllare, e che col nastro scopriranno subito l’assassino. Sono sicuro che me lo diranno. E ci sono anche gli altri nastri, gli dirò io molto soddisfatto, c’è una stanza di controllo e ci sono altri nastri, e due telecamere sono a infrarosso, e io non li ho ancora controllati, ma sono sicuro che esaminando quei nastri lo troverete l’assassino. Certo. Sono sicuro. Certo, mi diranno loro, e prenderanno i nastri e li guarderanno, e guardandoli si accorgeranno del tipo coi baffetti vicino alla gabbia delle scimmie, e così qualche guaio glielo farò passare. Le sue beghe e i suoi intrallazzi verranno fuori. Sicuramente ci sono, tutti abbiamo sempre qualcosa da nascondere, sicuramente anche lui i suoi peccatucci li avrà. Ma le immagini di questo nastro sono pulite e avrò tutta la notte per vedere e pulire i film delle altre telecamere, così non scopriranno nulla di certo. A operazione finita del volto dell’assassino non ci saranno tracce. Forse se ne vedrà il corpo, un corpo molto simile a quello dell’uomo coi baffetti, e forse si vedrà anche quel corpo mentre infila la lama nella schiena della vittima. Ma il volto no, quello purtroppo non si riuscirà mai a vederlo, perché la qualità delle immagini all’infrarosso non sarà perfetta, perché la confusione di corpi coprirà spesso gli spostamenti dell’assassino, perché l’assassino, quasi conoscesse la posizione delle telecamere, non si avvicinerà mai troppo alle telecamere, non rivolgerà mai la testa in modo da poter essere riconosciuto. Così gli indizi potranno soltanto favorire i sospetti: l’uomo, la gabbia, le scimmie, la gabbia aperta, la scimmia scappata, un diversivo per compiere il delitto, perché è stato così a lungo davanti alla gabbia, dov’era durante la festa, perché è l’unico che ha ancora la camicia allacciata, e la cravatta? Dov’era? Che faceva? L’ha vista qualcuno? Chi ha aperto la gabbia? Le solite storie. Perché, perché, perché? Chi? Le solite cose. Ma non riusciranno ad avere prove. Solo il sospetto. Ma anche il sospetto mi basta. Qualche guaio lo passerà anche lui. E quando non troveranno prove sarà il turno degli altri. Dov’era, cosa faceva, con chi? Perché? Perché? Lo domanderanno a tutti questi idioti mascherati da persone. E perché non ci sono impronte sul coltello? E dov’era quando ha sentito gridare? Ha visto niente o nessuno che possa aiutarci a identificare l’assassino? Conosceva la vittima? E anche la marchesa passerà qualche guaio per aver organizzato una festa come questa. La polizia sapeva e chiudeva gli occhi e intascava qualcosa, pochi spiccioli elargiti dalla marchesa, ma sufficienti a comperare il silenzio. Ma adesso, con un omicidio sulle spalle, come si fa a tacere, a far finta di non sapere? Eppure non scopriranno nulla: caso insoluto, assassino introvabile, caso archiviato. Assassino sconosciuto nonostante l’efficienza dei sistemi di sicurezza. Nonostante la presenza delle telecamere. Ma con chi se la possono prendere? Con me? coi miei uomini? Con le telecamere? O con l’assassino che ha fatto in modo di non farsi riconoscere durante l’omicidio? Percorro i corridoi, le stanze. Esco nel prato che circonda la villa. Passo davanti alla gabbia delle scimmie poi arrivo vicino alla piscina. Ignara, seduta sul bordo coi piedi a bagno c’è Virna, la figlia della marchesa. Come sempre distante da quanto le accade attorno, fa ciò che l’ho sempre vista fare da quando lavoro qui, la sola cosa che sembra capace di fare: leggere. Leggere senza capire. Anche a quest’ora, anche con tutto quello che succede in casa sua e davanti a lei. Mi accosto. Mi vede, distoglie gli occhi dal libro e mi sorride e mostra i suoi denti bianchi e il suo sguardo lontano. Agita i piedi nell’acqua. Le sfilo il libro dalle mani; è un libro di poesie, Le effemeridi della luna nera del poeta russo Eisenkievich. Scuoto la testa. Anche Virna scuote la testa. Sorride. Mi riprende il libro dalle mani. I suoi piedi creano onde concentriche nell’acqua. Torno a camminare verso la sala della festa col nastro in mano. «Dovresti stare meno appiccicato a quelle stupide telecamere!» mi grida dietro Virna. «Faresti meglio a leggere questo!» dice indicando il libro. Ride adesso. È allegra. A modo suo attraente, forse proprio per la distanza che riesce a mettere tra lei e le cose del mondo. Mi giro verso di lei e le sorrido anch’io, ma non le dico niente. |