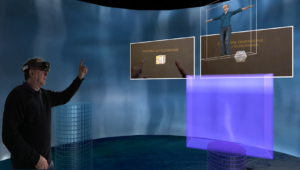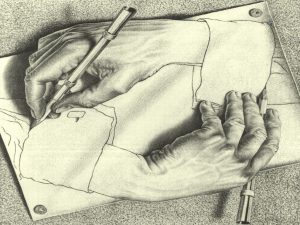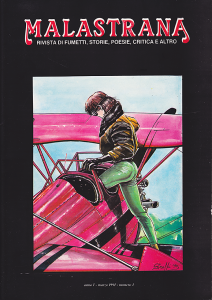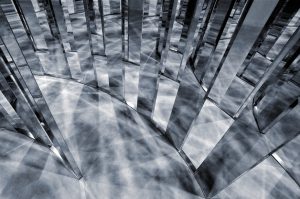Anche quella giornata era passata in fretta, e io già cominciavo a capire che i tratti del paesaggio potevano anche cambiare, c’erano state colline aspre e pianure radiose, campi d’orzo illuminati da cieli rossi di tramonto, montagne azzurre con le punte ritorte, laghi immensi come mari e sterminati muri di alberi, ma certe altre cose sarebbero rimaste immutate per l’intero viaggio: caldo, sole, umidità, pioggia. Non ci saremmo facilmente liberati di quegli ingredienti.
Riuscimmo finalmente a riprender fiato passando da una sponda all’altra del fiume su una specie di zattera di legno marcio, e potevamo respirare l’umidità dell’aria e riposarci sudando, invece che sudare trascinando gli zaini da un posto all’altro.
Prima c’era stato un autobus, rigorosamente pieno, con noi in piedi, stretti, pigiati contro gente sudata, tra odori rancidi e polli chiassosi legati per le zampe, e ventilatori appesi al soffitto che continuavano a spararci addosso ondate fredde d’aria che ci gelavano il sudore sulla schiena. Per quattro ore, per cinque soste per mangiare, con gente dappertutto, bambini, donne gravide, vecchie accompagnate da donne più giovani, ragazze che già allattavano bambini minuscoli come feti, finti storpi che ciondolavano lamentosi tra i passeggeri.
Poi il treno. Vagamente più comodo dell’autobus, se non altro perché ci si poteva sgranchire le gambe nei corridoi. Però: dieci ore, treno rigorosamente pieno, noi in piedi, stretti, pigiati contro gente sudata, tra odori rancidi di cibi cotti. Nelle soste, vecchie vendevano cibo stendendo le mani verso i finestrini e toccava scacciare quelle mani cariche di carni sanguinolente, pannocchie bruciacchiate o spiedini di topo. Mentre il treno procedeva a passo lento attorno c’erano alberi, altri alberi. A volte si scorgevano capanne, bambini che giocavano nel fango, baracche di legno in semicerchio.
Poi: altro autobus, naturalmente pieno, noi in piedi. E la gente che continuava a entrare, l’autobus gonfio di corpi, e ne salivano ancora a ogni sosta, e tutti con bagagli, borse, pacchi, scatole, animali, strumenti musicali, sacchi di patate e di pane e di caffè, vassoi di pasticcini, bottiglie con bevande colorate. I bambini piangevano, cagavano, urlavano. Eravamo lumache dentro a una piccola scatola. Come facciamo a starci tutti? mi domandai guardandoci così pressati.
Infine la zattera sul fiume. Il traghettatore era tranquillo, stretto al timone, insensibile al caldo, lo sguardo verso il centro dell’acqua. Di noi che attraversavamo gli interessava ben poco. Ne aveva visti migliaia transitare tra quelle sponde.
L’acqua fremeva di riflessi rossi; in cielo scorrevano nuvole larghe come ombrelli spalancati. Scendeva la sera. Orde di zanzare già erano pronte al pasto, mentre noi cercavamo di difenderci con pomate tossiche.
Più tardi eravamo a letto, anche se era difficile chiamare letto quella stuoia sulla quale ero sdraiato, sporca di polvere, dura contro il pavimento sconnesso. Prima, il pasto era stato frugale: riso e pollo, quel tanto che bastava per toglierci la fame. Poi la stanchezza ci aveva preso come in un abbraccio unto, e avevamo cercato la nostra baracca per dormire.
La notte era afosa. Il sudore ci si appiccicava addosso. Per fortuna le zanzariere tenevano lontani spiacevoli ospiti.
Eravamo stanchi, pure ci era difficile prendere sonno.
«È una bella stronzata» borbottò Aldo. Ripeterlo gli faceva bene, anche se lo ripeteva troppo.
« Siamo qua ormai, è inutile che continui» gli risposi brusco. Cominciava a infastidirmi, e finsi di addormentarmi subito per non dargli l’occasione di ripetersi ancora.
Ma non dormivo: fissavo il buio a occhi aperti, mentre fuori la giungla condensava i suoni del mondo, le grida, i fruscii di voli notturni.
Ripensai all’inizio della storia. Mi vidi con chiarezza al Cafè dell’Avventura, con gli amici di sempre attorno al solito tavolo mentre tutta la storia cominciava. Tre settimane prima. Sorseggiavo una tazza di caffè Mattari Yemenita, in bocca il retrogusto del cioccolato, e già qualcuno di noi aveva iniziato il giro di grappe, la prima da assaporare mescolando sulla lingua il gusto aspro del distillato con quello più amaro dell’ultimo caffè, e un’altra per scacciare il sapore della prima, e un’altra ancora per dimenticare le cose della vita.
Anch’io presto sarei passato alle grappe, perché ne avevo molte di cose da dimenticare. Ero lì apposta quella sera: per distrarmi, per trovare nella sequenza di caffè e grappe e nei racconti di quelli seduti ai tavoli ottimi argomenti per frullarmi il cervello, e scrollarmi di dosso il desiderio feroce per occhi e labbra sparite da poco.
Forse non sapete che chi va al Cafè dell’Avventura lo fa per due motivi: il caffè e le avventure. Al Cafè dell’Avventura il caffè è Caffè, con la maiuscola ben in vista, e quando il vecchio Peppuccio s’avvicina al tuo tavolo non ti chiederà mai se vuoi un caffè; piuttosto la sua domanda sarà: «Che caffè stasera?» e se lo lasci continuare sentirai: «vuoi un Ghimbi Etiopico o il Tachiras Venezuelano? Vai col Mandheling superforte, o stasera hai il palato giusto per lo speziato Bugishu Ugandese?»
E poi ci sono le avventure, al Cafè dell’Avventura. Da vivere, da raccontare, da ascoltare con la tazza di caffè in mano. Quelli seduti ai tavoli stanno sempre per partire o sono appena tornati da un’avventura straordinaria, per cui c’è sempre qualcuno pronto a raccontare storie incredibili. Al Cafè dell’Avventura ci piace esagerare. E che le storie siano vere o false poco importa; basta che ci facciano sognare.
Così anche quella sera io e i miei compari eravamo al Cafè dell’Avventura a bere caffè e grappe e in procinto di raccontarci storie. L’atmosfera però era un po' diversa dal solito, più elettrica. Natale era alle porte, e col Bambinello già bello che pronto a scender dalle stelle arrivavano le vacanze e molti, probabilmente tutti lì al Cafè dell’Avventura, non aspettavano altro, e già preparavano i bagagli.
Bè, no, tutti no. Io no. Io restavo. Diciannove giorni e qualche ora prima la mia donna, il mio amore, quella donna che non volevo più nominare, era sparita senza spiegazioni. Svanita come una cometa che lascia il sole. E quindi non contavo di viaggiare. Gli altri partivano, io invece restavo in casa a leccarmi le ferite.
Ma mi sbagliavo, e lo scoprii presto.
Quella sera qualcosa era in agguato al Cafè dell’Avventura. Chiaro, non c’era nulla di strano nel gesto di Vanni, quando dalla tasca cacciò fuori una rivista e la sfogliò bevendo grappa e poi, dopo minuti di quel lento girar di pagine, a un certo punto disse: «Hei, guardate questa!» mostrando la pagina aperta su una foto di piantagioni tropicali di caffè, col titolo che recitava: “Maragogype special”: Alla scoperta del caffè più buono del mondo.
Nulla di strano. Ma io ero sospettoso e cupo. In quei giorni mi pareva che il mondo avesse preso una piega in salita. Cominciavo a scivolare nell’irrazionale, trovavo intorno piccoli ma significativi segni di un complotto alle mie spalle. La sparizione della mia donna, per esempio. Il primo segno. E altri segni li trovavo nelle congiunzioni di eventi astrali, nei magici artifici del cielo che si mescolavano a infausti eventi della Terra. Le macchie solari, per esempio, che già da settimane si agitavano sul sole. Molti pensavano che quelle macchie minacciavano la nostra salute, rompevano fragili equilibri psichici. Anche io lo pensavo. Forse distruggevano persino antichi amori. Forse il mio. E poi c’era la cometa, gli astronomi ce l’avevano annunciata, luminosa più delle stelle luminose. Ma perché una cometa decide di presentarsi proprio a Natale? Cos’è che voleva annunciarmi?
Insomma, ero attento a ogni cosa, e in ogni cosa trovavo segni. E per ogni nuovo segno rivelato, sempre più mi pareva che si venisse componendo la trama di un complotto a mie spese. C’erano segni dappertutto. Segni. Nell’interazione tra quei segni non poteva non esserci l’opera di una divinità scontrosa che si faceva beffe dei nostri destini miseri. E soprattutto del mio.
È così che pensavo, e pensavo male, lo so, ma era quello il modo in cui mi andava la testa in quei giorni. Capite quindi che subito squillò un campanello quando Vanni disse: «Guardate questa!» mostrando la rivista. Niente di strano. Pure, in quel gesto troppo enfatico ci vidi un altro segno.
Non chiedetemi perché, non saprei spiegarlo. Lo sentivo e basta.
E poi, va anche detto a mia discolpa: forse pensavo male, è vero, ma in quel caso avevo ragione. Il complotto c’era davvero.
Lo scoprii dopo, quando Vanni, lette poche righe dell’articolo, disse guardandomi: «Il caffè più buono del mondo coltivato tra giungla e colline… La storia sembra fatta apposta per te. Perché non te ne vai a prenderci un po' di questo caffè, e così ti scordi anche la tua donna?»
E subito tutti presero a fissarmi come se quella fosse la proposta più ragionevole del mondo. A dire il vero a me sembrò una stronzata, ma una stronzata innocua, buttata lì tanto per parlare. Ma poi tutti continuarono a discuterla, quella stronzata. E stranamente tutti parlavano con me. Parti, vacci tu, dài, insisteva Lucio, e cosa c’era di meglio per distrarsi dalla scomparsa di quella donna che non volevo nominare? Dimentica tutto e subito, mi consigliò Enrico, detto il Professore. Elabora il lutto in fretta.
Come avrei potuto rifiutare quel richiamo all’avventura?, mi dissero tutti gli altri. Sembravano il coro della notte di Natale.
Dovevo partire.
E se per un po' continuai a pensarla come una bella stronzata che ci teneva allegri attorno al tavolo, già dopo la quarta grappa quell’idea era diventata una prospettiva attraente come un miraggio. Un buco perfetto nella sabbia in cui infilare la testa.
La storia intera venne fuori dopo, e solo allora capii: altro che sbirciata casuale all’articolo sulla rivista! Altro che caffè più buono del mondo! Tutti sapevano tutto prima ancora che Vanni dicesse la sua storia sul caffè. Ero io il predestinato, il cacciatore di caffè. Avevano preparato la cosa chissà da quanti giorni. Apposta per me. Contro di me. A quel punto mancava solo che mi infilassero un biglietto d’aereo tra le mani!
E non era finita, naturalmente. Il biglietto non lo cacciarono, ma erano così certi che sarei partito che mi chiarirono quel che ancora mi mancava per farmi una buona idea del loro bel progettino su di me.
«Se è facile non ci piace» disse Vanni ribadendomi il motto di noi del Cafè dell’Avventura. «E non piace neanche a te, no?» aggiunse.
Cosi venne fuori anche la storia dell’itinerario di viaggio già adattato per me. «Com’è vero che tutte le strade portano a Roma» pontificò Vanni sorridendo «è anche vero che tutte le strade portano al caffè più buono del mondo» e girò la pagina della rivista che ancora teneva in mano per mostrarmi la mappa dei territori di quel prezioso caffè.
Bell’idea, pensai. Sapevo già cosa intendeva: scordati il percorso rettilineo, breve, semplice! Ancor prima di guardare la mappa ero sicuro che la distanza tra me e quel caffè sarebbe stata molta, e la strada faticosa. E infatti…
E non era finita, naturalmente. La ciliegina sulla torta, anche se non è così che me la misero i miei amici cari, l’avevano tenuta per chiudere in bellezza: Aldo, che quella sera non c’era, chissà come mai, veniva con me. E mentre Vanni me lo diceva tutti guardavano da qualche altra parte , trattenendosi dal ridere.
Ora, dovete sapere che Aldo non è esattamente Indiana Jones. Schivo, silenzioso, un metro e novanta per centoquaranta chili. Con la propensione a sudare, estate e inverno. E a lamentarsi. Estate e inverno. E soprattutto è uno dei pochi tra noi al Cafè dell’Avventura che le storie ama più ascoltarle che viverle. Aldo è il perfetto prototipo del pantofolaio incallito, del pensionato precoce; il suo ideale di avventura è una birra da ciucciarsi in poltrona e un film d’avventura in tv. Estate e inverno. Quindi è il compagno perfetto per finire in un posto come quello dove mi volevano spedire, col cento percento di umidità e mille situazioni per tenere il culo in moto e mille ragionevoli motivi per lamentarsi.
Insomma, capite la portata del complotto? Gli amici cari si erano ingegnati per bene per offrirmi un modo fantastico per distrarmi. Un magnifico regalo di Natale confezionato coi fiocchi!
Aspettando che mi decidessi mi guardavano come si guarda a un ricordo: in lontananza. Erano talmente certi che non avrei rifiutato, che per loro era come fossi già partito.
Avrei potuto rifiutare?
In quei giorni ero debole, triste, manipolabile. Non rifiutai.
È così che tre settimane dopo, la vigilia di Natale, io e Aldo eravamo lì, dentro a una baracca di legno, a sudare e lamentarci, e provare a dormire.
L’umidità era soffocante e ci misi molto ad addormentarmi. Pensieri fissi su una donna mi tenevano sveglio, e anche il ronzio di zanzare affamate che cercavano buchi nella zanzariera per raggiungermi la pelle.
Poi sognai che Aldo si alzava dalla sua stuoia e strappava la mia zanzariera gridando: «È tutta colpa tua!» e prendeva a colpirmi con le sue grosse mani. Mentre cercavo di ripararmi dal suo assalto dietro di lui compariva un’ombra e io sapevo che era la donna che non volevo nominare. Era venuta a salvarmi. Toccò Aldo su una spalla e gli bisbigliò all’orecchio frasi di indicibile dolcezza, e subito Aldo smise di colpirmi e tornò a sdraiarsi. Quando la donna che non volevo nominare uscì dalla capanna anch’io sprofondai nel sonno.
Il primo chiarore dell’alba scatenò un concerto di canti e urla rauche di chissà quali animali. La giungla si svegliava presto, e noi ci svegliammo con la giungla. Ci vestimmo con lentezza cullata dall’umidità. Nelle scarpe, rovesciate come bicchieri vuoti, cercammo ospiti indesiderati. Il tempo di prepararci per la colazione e già grondavamo.
Da una baracca lì vicino una vecchia ci servì pane molle e un caffè troppo annacquato in tazze un tempo bianche. Gli uccelli frusciavano tra le piante, il loro canto era violento. Non parlammo molto. Quel pane e quel caffè non ci aiutavano a riprenderci dalla notte. Aldo era stanco, si vedeva, e io non volevo dargli l’occasione per lamentarsi. Non gli dissi del sogno.
Poi arrivò Carlos, la guida ingaggiata la sera prima, ci salutò che stavamo ancora masticando. Era pronto a partire. Ci sorrise e ci aspettò in piedi. Era un omino dalla pelle scura e il corpo muscoloso.
Lasciammo il villaggio che il sole era apparso da poco oltre i tetti di paglia del villaggio. Intorno uomini camminavano con borse tra le mani e sacchi di plastica, donne seguivano carretti carichi di erbe e trascinati da muli. Due bambini ci accompagnarono fino al ciglio della giungla facendoci gesti curiosi. Eravamo una strana coppia di bianchi, Aldo soprattutto era strano, con la sua mole da gigante. Un ragazzino mi toccò la testa, come a voler esplorare le differenze tra i miei capelli e i suoi.
Poi ci infilammo nella vegetazione fitta. Carlos procedeva a passi lenti, ogni tanto si voltava per controllare se c’eravamo ancora. Alzando la testa scorgevo il cielo azzurro oltre gli alberi più alti. Di notte ci sarebbero state le stelle, pensai. Forse si vedeva la cometa. Pensai alle macchie solari che in quel momento scalpitavano sul sole senza che io potessi farci nulla.
Se dico: “eravamo infilati nella fitta vegetazione ” subito dovreste immaginare colori: verdi in molte sfumature, il rosso di fiori tropicali, raggi di sole che trafiggono il verde e l’accendono. Profumi di erbe marce. E ronzii d’insetti svolazzanti.
Se è questo che immaginate fate bene. Essere infilati nella fitta vegetazione è così. Ma la sostanziale differenza tra l’immaginare e l’esserci è esserci sul serio. Un mondo di differenza. Esserci significa molte piante, molti colori, molti ronzii, ma anche di più: significa caldo, sudore, fatica, e soprattutto pericolo.
Noi eravamo infilati nella fitta vegetazione.
Poche ore di cammino e già mi era chiaro che le creature grosse, i felini, i cani selvatici e quant’altro ci assomigli, le bestie fameliche di ogni tipo, o le scimmie incazzate, se ne stavano alla larga. Loro erano grossi, ma noi eravamo quasi sempre più grossi di loro: mangiarci non ci riuscivano, farci a pezzi neanche, quindi era meglio per loro starsene lontani. Quindi potevamo solo stare attenti alle cose piccole ma ancora visibili: le piante urticanti, le zanzare, i serpenti, gli scorpioni, i millepiedi o le sanguisughe, le lucertole o i loro parenti ipernutriti. Per il resto, il microscopico, l’innumerevole, l’innominabile, era inutile sprecarci tempo. Sto parlando di insetti, parassiti, esseri volanti e saltanti non identificati. Tutti piccolissimi e poco socievoli. Tutti affamati. Miliardi di creature ansiose di infilartisi in un orecchio o una narice, che ti si appiccicano tra le dita quando sfiori una foglia e poi si scavano in silenzio una strada attraverso le unghie, sottopelle, e ti ingravidano.
Di sicuro erano pensieri come questi a rotolare in testa ad Aldo mentre eravamo lì infilati nella fitta vegetazione. Bastava guardarlo per capirlo. Grondante di sudore, guardingo e con gli occhi accipigliati, pareva dover crollare da un momento all’altro come un elefante abbattuto. Ovvio, si era pentito di avermi accompagnato. Al Cafè dell’Avventura le storie degli altri sono sempre grandiose davanti a una tazza di buon caffè. Fantasticarci su non costa nulla. Ma ora gli era evidente il significato di essere in un posto, esserci sul serio.
«Questa storia del caffè è una stronzata» disse infatti. Per la decima volta nelle ultime quattro ore. «Tutto questo viaggio è una stronzata.»
Mi fermai a scrutarlo, ma non risposi. Dalla borraccia tirai due sorsate di acqua tiepida e ripresi a camminare. Nonostante fatica e pericoli a me non dispiaceva essere lì, troppo impegnato a camminare per pensare a quella donna che non volevo nominare.
E non era poi così terribile; a volte davanti a noi c’era un accenno di sentiero, e comunque Carlos se la cavava alla grande. Avanzava sicuro nonostante le ridicole infradito che portava ai piedi. Ci puliva la strada con colpi precisi di machete, trascinandosi dietro uno zaino che era due volte il nostro.
Nel pomeriggio sostammo in una radura e Carlos ci preparò da mangiare: pollo con riso. Era freddo e molliccio, ma la fame era troppa per fare gli schizzinosi. Intanto il cielo si era fatto bianco. Aldo non si lamentava più e io non sapevo se esserne felice o preoccupato. Da ore ormai camminava in silenzio, ultimo del nostro terzetto bizzarro. Ripensai al sogno della notte, ai pugni violenti che mi assestava in testa urlandomi addosso la colpa per peccati a me ignoti. Evitai di esplorare il significato dell’ombra che era venuta a salvarmi.
Poi cominciò a piovere. Era un concerto bellissimo quello delle gocce sulle foglie, un rumore di mille animali al piccolo trotto a fare da base ritmica ai frinii delle cicale e degli altri chiassosi abitanti degli alberi. E non mi preoccupai troppo dell’acqua che mi bagnava. Ero già grondante di sudore, e trovai piacevole l’idea che con la pioggia potevo almeno vedere cos’era a bagnarmi.
Ma quel piacere durò poco, perché la pioggia fu un richiamo per le sanguisughe. Coprimmo bene piedi e caviglie, ma presto diventò impossibile star dietro all’assalto di quei mostri che a ogni passo si attaccavano alle scarpe in cerca di sangue. Aldo vide una macchia di sangue spuntargli sulla stoffa dei pantaloni come un grande fiore rosso e urlò con un grido acuto che pareva quello di una scimmia. E anche io non riuscii a evitare due o tre succhiate. La guida rideva sentendoci imprecare in una lingua che non capiva. «No problema» ripeteva. Ogni tanto scacciava le sanguisughe dai suoi piedi nudi con un colpo di mano.
Continuò a ripetere «No problema» anche quando fui morso da un piccolo serpente. Me l’ero cercata. Avevo appoggiato la mano contro il tronco di un albero e il morso non s’era fatto attendere. Gridai, più per l’idea del morso e per il sangue che per il dolore. Ma Carlos vide il serpente scivolare tra i rami e non sembrò preoccupato. Non era velenoso, mi spiegò mentre la pelle attorno al morso si gonfiava. Cercò foglie tra le foglie, ne strappò un ciuffo da una pianta non lontana e dal gambo strizzato fece gocciare sulla ferita un latte profumato che mi calmò il dolore. «No problema» lo disse molte volte ancora, mentre Aldo, torvo e in silenzio seguiva l’operazione. Non capii bene il senso di quel suo sguardo, ma l’immaginai a studiare vendette adeguate per ringraziare a tempo debito gli amici del Cafè dell’Avventura.
Dormire non fu difficile. Eravamo sudati, stanchi. Carlos sistemò le tende in uno spiazzo d’erba e di rami spezzati. Arrivava la notte rapida, portando nuvole di zanzare. Carlos ci servì del pollo freddo e riso in scodelle di plastica. Era difficile capire la differenza tra il pollo e il riso. L’acqua nelle borracce era calda come tè e disgustosa. Il cielo era pieno di stelle. Ci infilammo in fretta nelle tende senza forza per protestare. Non pensammo ai mille pericoli che potevano arrivarci addosso. Non sognai neppure.
Il secondo giorno non fu diverso dal primo: alberi, insetti, fruscii, pericoli, il canto delle cicale, la pioggia pomeridiana. Ma era diversa l’aspettativa. Entro sera saremmo arrivati a un villaggio, e quell’idea bastava a darci la carica per continuare.
Camminavamo già da tre ore e Carlos ci indicò qualcosa puntando un dito tra la vegetazione. In quella direzione vidi il profilo di una costruzione in pietra. In breve eravamo al centro di un piccolo gruppo di edifici antichi e divorati dalla giungla. Affascinato studiai senza capirli i segni che scorgevo sulle pareti sotto a liane e radici.
«Maya» disse Carlos. Sembrò preoccupato. Forse anche per lui quelle pietre erano una scoperta. Gli uccelli avevano smesso di schiamazzare. E anche le cicale.
Ci aggirammo inquieti tra le rovine in attesa che qualcosa di ignoto decidesse di manifestarsi. Avevo visto troppi film e mi pareva impossibile trovare rovine nella giungla senza che nulla di fantastico e minaccioso accadesse. Ma non accadde nulla. Aldo salì sbuffando in cima al mucchio di pietre più alto e mi stupì molto la sua inattesa intraprendenza. Forse cominciava a prenderci gusto, pensai. Carlos e io dal basso lo guardavamo: era una specie di divinità che sorvegliava quella città antica. Spalancò le braccia e disse: «Non si vede niente.» Poi cominciò a scendere e due pietre dissestate ci franarono vicine e rimasero immobili nell’erba.
Ripartimmo quasi subito. La pioggia arrivò nel pomeriggio e ci accompagnò fino al tramonto. A un tratto vidi grandi torri di terra scura sbocciate dal terreno, svettavano verso il cielo come guglie gotiche. Ai piedi delle torri un movimento frenetico di formiche. Mi chinai per osservarle. Erano enormi, minacciose, ronzanti. E altre formiche le vidi zampettare in fila indiana trascinando frammenti di foglie verso le torri. Erano miriadi, e sembravano perse in una complessa danza senza fine.
Raggiungemmo il villaggio che eravamo sul punto di crollare. Pioveva ancora, e la notte arrivava in fretta. Dopo aver camminato a lungo con la giungla intorno, di certo fu uno spettacolo strano quello che ci si aprì davanti: la giungla d’improvviso si fermava per dare spazio alle case di legno. Capii il motivo di quell’arresto della vegetazione solo quando fummo più vicini. Oltre le baracche di legno c’era un fiume: immenso, vivo con i riflessi dell’ultimo sole. C’era odore d’erba marcia, e d’acqua che ristagna, e grida di bambini. Vedere quell’acqua lenta ai confini della giungla mi fece pensare a un sorriso, e mi sentii felice per la prima volta da molto tempo.
La gente del villaggio ci accolse festosa: i bambini ci corsero incontro, le donne ridevano e si coprivano la bocca con la mano. Non capitavano molti bianchi da quelle parti, e non credo avessero mai visto un omone come Aldo, se non forse nei loro sogni.
Mangiammo in abbondanza. Pollo, riso e verdure, per cambiare, ma almeno quel cibo era stato appena cotto e per noi era come assaporare un cibo sconosciuto.
Carlos venne a salutarci che era l’alba. Se ne tornava indietro, e ci affido a un tipo minuto, ma con le braccia forti e un gran sorriso. Manuel si chiamava.
Già eravamo sulla sua barca, Aldo davanti, io e Manuel dietro, quando riprese a piovere e presto si alzò un vento forte che costruiva sull’acqua onde preoccupanti. Manuel sembrava tranquillo, teneva il timone come navigasse sopra a uno specchio. Ma la barca prese a beccheggiare molto, e il vento ci tirava addosso acqua di fiume e noi ci spaventammo, e in breve fu chiaro che continuare era una follia. Dovevamo tornare a terra.
Ma era troppo tardi e a poco valsero i tentativi di controllare la barca. Per fortuna si rovesciò che eravamo già vicini alla riva. Nuotammo come potevamo, aggrappati alla barca capovolta. Aldo sembrava una balena spiaggiata, urlava tra acqua e fango agitando le mani. Solo quando toccammo terra mi accorsi del suo braccio, del sangue. Si era ferito non so come. Urlava di dolore, non smise neanche quando trovammo riparo in un villaggio vicino, e una donna centenaria gli pulì il braccio con tenerezza sorprendete, sfregando sulla ferita grandi foglie bianche.
Dopo era notte e pioveva ancora e il vento ci spazzava addosso la pioggia. Dentro la capanna Aldo si lamentava: «Voglio tornare a casa» diceva, pur sapendo che era impossibile. Piccole barche attraccate a riva sbattevano tra loro spinte dalla tempesta. Mangiammo poco e ascoltammo il rumore della pioggia.
Al mattino era tutto finito, l’aria profumava di fiori. Pezzi di canne e tronchi scivolavano sull’acqua tranquilla. Avevamo fretta di partire, arrivare, e per un giorno intero scivolammo sul fiume. Insetti curiosi si avvicinavano a noi. Dal centro dell’acqua ammiravo le mura altissime fatte di alberi oltre le rive. I canti di uccelli ci fecero compagnia. Manuel silenzioso a tratti spingeva la barca con colpi di remo. Aldo si sosteneva il braccio ferito con la mano sana, si lamentava ogni tanto con un mugolio mesto. Ma nessuno disse una parola fino a sera. Poi la riva, la tenda, il fuoco, il cibo, la notte, le grida di animali, il sonno.
Era ancora presto al mattino quando navigammo verso un villaggio grande abbastanza da assomigliare a una città. Piccole imbarcazioni a motore si affollano attorno al mercato chiassoso distribuito lungo la riva. Eravamo appena scesi dalla barca quando Manuel mise in giro la voce che cercavamo un aereo, e cinque minuti dopo orde di uomini ci circondarono per proporci l’affare, come fossimo carne fresca e loro mosche.
Lì erano abituati a gente come noi, e ci trattarono per quello che eravamo: soldi, e la possibilità di campare un altro giorno. E di soldi ne volevano tanti per trasportarci. A sentir loro, era Aldo il problema. Gli aerei sono piccoli, ci dicevano, e l’amico gigante troppo pesante. Ognuno gridava sulla voce dell’altro. Solo i nostri soldi riuscirono a convincerli che ce la potevamo fare anche con Aldo a bordo. Ma impiegammo molto a contrattare, e tutta la nostra pazienza, mettendo infine in mano all’uomo che ci aveva fatto l’offerta migliore molti più soldi di quelli previsti.
Con un taxi l’uomo ci accompagnò alla pista di volo e ci mollò davanti all’aereo e al pilota. Erano piccoli entrambi, entrambi sporchi e poco affidabili. «Uomo pesante» disse subito il pilota vedendo Aldo. Scosse la testa e sputò per terra. Era poco più di un ragazzino ma si muoveva come un adulto. Io guardai Aldo, preoccupato.
Il decollo fu rumoroso e fatto di false partenze e sussulti sulla pista polverosa. Ma poi ci trovammo in alto, dentro a un cielo brillante e sopra a una terra verde che sembrava troppo lontana. L’odore dolce del carburante non lasciava l’abitacolo.
Troppo peso, molto pericolo. Continuavo a pensarci. Aldo era muto e anch’io, e mi immaginavo quel giocattolo volante che precipitava, mentre io usavo gli ultimi secondi di vita per scagliarmi contro Aldo e urlargli: «È colpa tua!, è colpa tua!»
Non posso dire che gli uomini a terra avessero totalmente ragione; non sarei qui a raccontarlo. Ma a un certo punto mi fu chiaro che i loro discorsi non erano solo scuse per spillarci soldi. L’aereo era un biposto. Noi eravamo in tre, e uno dei tre col peso di due uomini. E se in aria il peso in eccesso non ci creò troppi problemi, ce ne accorgemmo invece all’atterraggio. Avevamo già toccato la pista, e rallentavamo per fermarci, già con la convinzione d’avercela fatta, quando il carrello cedette con uno schianto e l’aereo si piegò su un fianco. Quando l’ala toccò il terreno ruotammo di lato, l’ala si spezzò e ce la lasciammo alle spalle e subito dopo anche l’aereo fece la stessa fine con un rumore di ossa spaccate.
Restammo seduti nei resti d’aereo mentre la polvere si diradava, increduli per averla scampata. Poi Aldo prese a lamentarsi e mi spiegò urlando che aveva di nuovo battuto sul suo braccio ferito. Effettivamente, c’era del sangue che arrossava la fasciatura. Ma poi si azzittì. Credo si spaventò leggendomi in faccia la paura. Dovevo essere bianco come un ectoplasma.
Scendemmo a fatica dal troncone di aereo e ci allontanammo dalla pista zoppicanti. Il pilota ci inseguiva urlando e insisteva per farci ripagare il suo aereo distrutto: piangeva, ci si parava davanti con le mani tese. Voleva i soldi per il suo aereo.
Non gli spiegammo dove poteva andarseli a cercare quei soldi. Ma non lo picchiammo neppure. Lo lasciammo a piangere seduto in terra, a raccontare a chi voleva ascoltarlo la storia del suo aereo perduto.
Finalmente arrivò la sera, e con la sera la calma. Avevamo trovato una specie d’albergo costruito sull’acqua, e avremmo dormito in un letto vero e quest’idea ci consolava. Così, prima di cena passeggiavamo tranquilli per le strade di quella città fluviale, con la convinzione che nulla più ci poteva capitare. Ma non avevamo fatto i conti con la notte, con l’illuminazione scarsa e i lavori in corso in quella strada che finiva sul fiume. Aldo stava parlando e d’improvviso la sua voce diventò un urlo e poi un lamento seguito da un tonfo. Ci misi un po' a capire la causa della sua repentina sparizione e dopo non riuscii a trattenermi dal ridere. Povero Aldo, era finito dentro una buca a fianco di un canale che scaricava nel fiume.
Uscì dalla buca nero per l’incazzatura e per la melma ben poco profumata che lo copriva tutto. Camminò lamentandosi fino davanti a una luce e così lo vidi bene. Il braccio gli penzolava dalla spalla, la fasciatura appena rifatta grondava d’acqua di scarico. Si era trasformato in un quintale abbondante di fogna ambulante. Come si poteva non ridere a guardarlo?
Tutto questo per un po' di caffè, mi dissi più tardi. Ero sdraiato su un’amaca a ammirare il fiume. Aldo era in bagno a lavarsi e lamentarsi. Avremmo potuto raggiungere facilmente la piantagione di caffè in un solo giorno con un aereo vero, pensai. In fondo, pensai, eravamo quasi ridicoli, io che riuscivo a farmi mordere dal primo serpentello di passaggio, e Aldo che saltava nell’acqua di fogna come un tuffatore. Proprio una bella coppia di eroi da fumetto! E in quel momento avrei volentieri scambiato quell’amaca col letto di casa e con un bel film d’avventura in tv. Ma poi vidi il mio letto come l’avessi davanti. Mi ripensai in quel letto con la donna che non volevo nominare, ricordai il suo corpo che mi aveva dormito a fianco per tante notti. E mi vidi pure in un futuro non lontano, da solo in quel letto vuoto e grande, e allora mi scossi.
No, quel viaggio funzionava esattamente come avrebbe dovuto. Guarivo dal male per un’assenza impegnando i miei pensieri nel presente. Piuttosto, era la fine del viaggio che avrei dovuto temere: dopo sarei finito dentro a una normalità grigia, e nel mio letto vuoto e troppo grande.
Il fiume era una striscia scura ripiena di riflessi. Guardandolo presto precipitai nel sonno e Aldo non mi svegliò. Sognai la donna che non volevo nominare. Spuntò fuori dal fiume vestita di rosso e mi chiese spazio nell’amaca e mi si assestò a fianco e mi baciò mentre ci dondolavamo assieme. La notte passò in fretta tra quei baci. Mi svegliai col canto di molti uccelli, con la pelle che mi prudeva dappertutto. Di certo le zanzare avevano apprezzato il mio sonno sotto alla veranda.
Ormai eravamo a un passo dalla fine del percorso perverso ideato per noi dai nostri cari amici del Cafè dell’Avventura per trasformare il facile in difficile. Ansiosi di arrivare, un’ora dopo il mio risveglio già correvamo dentro a un autobus traballante, ma seduti questa volta, e ben determinati a raggiungere la nostra ultima meta: le piantagioni del caffè più buono del mondo.
Ma non fu così semplice, naturalmente. L’autobus a metà strada spaccò un asse con un rumore che pareva un’esplosione, e fu complicato arrivare al villaggio più vicino, e poi trovare un mezzo che ci portasse avanti per più di pochi chilometri alla volta. Salimmo su un carretto trainato da un mulo, poi un trattore, e un taxi carico di balle di fieno. Attorno c’erano solo infinite piantagioni di banane.
Alla fine fu un pick-up scassato ad aiutarci: ci trovammo a far compagnia a un bel mucchio di capre puzzolenti, ma in sei ore eravamo a Dos Rios. La strada era stata polvere e altra polvere e arrivammo bianchi come fantasmi e tutti ci guardavano e ridevano mentre camminavamo in cerca di un posto per dormire.
Due fiumi attraversano Dos Rios e quasi si toccano nel centro del paese. C’e un ponte che scavalca il Rio Dulce e subito dopo si incontra l’altro ponte sul Rio Amargo. Io ero seduto lì, su una fascia di terra tra i due ponti. Per un tempo sospeso guardai quelle acque sorvolate da uccelli pescatori; in lontananza vedevo colline boscose, e in cielo grandi nuvole bianche. In quel momento fui certo di sapere perché eravamo partiti: per trovare quella visione. E contemplare acqua e terra e cielo in quel punto, all’incrocio tra i due fiumi, dove il dolce incontra l’amaro.
Il giorno dopo, un taxi ci portò in collina tra i boschi, e finalmente, sotto gli alberi e tra l’ombra, vidi i filari con le piante di caffè. Molti uomini si aggiravano tra le piante e raccoglievano le ciliegie di caffè e le lanciavano in grandi ceste appese sulle spalle. L’odore pungente del caffè maturo entrò nell’auto inebriandoci.
Finalmente eravamo nel regno del Maragogype Special, il caffè più buono del mondo ! Era la terra inseguita per tutti quei giorni! Ero emozionato, e credo che anche Aldo lo fosse. Mi sorrise.
Ci fermammo a El Bosque, un villaggio in cima a una collina. Attorno, in zone disboscate, per terra, c’era un mare infinito di chicchi di caffè stesi a seccare sotto il sole. Un uomo camminava sui chicchi rivoltandoli con un grande rastrello. Costruiva lunghe scie rigate su quella superficie immensa.
Visitammo una fattoria, camminavamo stupiti tra le case e le attrezzature per la lavorazione del caffè. Il caffè era nell’aria, nei colori, negli aromi, nelle mani degli uomini impegnati a setacciare i chicchi, nelle macchine di tostatura che lanciavano in aria grandi sbuffi di vapore aromatico.
A pranzo eravamo con la gente della fattoria. Parlavano poco. Alla fine ci servirono il caffè ridendo, e io fui scosso da brividi: nella tazza che tenevo in mano c’era il caffè più buono del mondo. La sua fragranza speziata mi aprì una strada nei sensi. Era…
No, non voglio dirlo.
Ma sorrisi. Lo sorseggiai con lentezza infinita. E immaginai il racconto che avrei costruito su quel momento magico per gli amici del Cafè dell’Avventura.
Nel pomeriggio finimmo in un capannone di stoccaggio. Grandi pile di sacchi di tela pieni di caffè riempivano lo spazio da terra al soffitto. Lì il caffè si sarebbe potuto respirarlo, tanto l’aria era densa di polvere di caffè.
Comprammo due sacchi di Maragogype Special, e a quel punto, con i sacchi in mano, ci fu chiaro che non avevamo più ragioni per restare. Così tornammo in città, già con la nostalgia per quella fattoria visitata, per quella gente che viveva coltivando il caffè più buono del mondo.
Il viaggio era concluso, ormai. Eravamo contenti. Eravamo stanchi. Eravamo affranti, disperati. Davanti a noi, solo la strada del ritorno: rettilinea, facile, noiosa.
Trovammo un autobus con ammortizzatori veri, un taxi, una città di cemento, un aeroporto, bagagli abbandonati dopo il check-in, la vista di decolli a catena oltre i vetri di una sala d’attesa.
Del volo verso casa non ricordo molto. Era un volo qualsiasi, come mille. Grandi ciuffi di nuvole scorrevano sotto di noi. La notte li portò via. Atterrammo che era già mattino.
Eravamo tornati. Sani e salvi, o insomma, quasi. Il viaggio era durato il tempo di un sogno o di un incanto. Il Bambinello era sceso dalle stelle, la cometa era arrivata e già se n’era volata tra le stelle. E delle macchie solari non sapevo più nulla. Se c’erano altri segni nell’aria ad avvertirci di un nuovo pericolo imminente, non ci feci caso.
Atterrati al mattino, la sera già eravamo al Cafè dell’Avventura, stesso tavolo di sempre, stessa ora, stesso gruppetto di compari, Vanni e il Professore, e Lucio e tutti gli altri bastardi che ci avevano spedito in giro per il mondo, e Peppuccio dietro al bancone a preparare i suoi fantastici caffè, e Aldo al mio fianco, gigante fiero, con la sua fasciatura al braccio ben in vista, quasi fosse l’eroe di una guerra dei poveri. Non lo avrebbe mai ammesso, ma ero certo che si era divertito per la prima volta in vita sua.
Quanto a me, beh, ero sopravvissuto. Al morso del serpente, alle sanguisughe e alle piogge, ai fiumi in tempesta, e agli aerei poco propensi a restarsene interi. Ero sopravvissuto persino a Aldo. Così sarei riuscito a sopravvivere anche al resto, al ritorno dentro a una vita grigia, e pure all’assenza della donna che non volevo nominare. O insomma, quasi. In fondo erano solo cinquantasei giorni e qualche ora che non sapevo più nulla di lei. Magari mi sarebbe servito un altro giorno, o una settimana, o un mese, ma prima o poi…
Comunque avevamo il caffè. Due grandi sacchi del caffè più buono del mondo: Maragogype Special, dal produttore al consumatore. Regalo per Peppuccio, omaggio al Cafè dell’Avventura.
«Abbiamo il caffè» annunciai solenne ai compari attorno al tavolo. Non aspettavano altro, lo vidi dal bagliore nei loro occhi. E così cacciai fuori da una borsa i due sacchi di juta col caffè, con lentezza, quasi fossero ostie consacrate tra le dita di un prete a messa, e li lasciai cadere sul tavolo con un bel tonfo, così che tutti si accorgessero del tesoro che portavo.
L’attenzione generale fu presto catturata. Ogni sguardo era rivolto ai sacchi, e allora intuii che il momento era quello giusto, e dissi quel che tutti aspettavano: «È stata dura, ma ce l’abbiamo fatta.»
Al Cafè dell’Avventura la conosciamo bene questa frase. È una formula magica. È come voltare la copertina di un libro: apre all’ascolto di un’avventura nuova. Così, dopo quella frase, tutti si assestarono bene sulle sedie, come attorno a un fuoco la notte in un deserto. Aldo in silenzio al mio fianco mi lasciava fare e dire, i due sacchi di caffè sul tavolo erano i testimoni di una verità irrefutabile: ce l’avevamo fatta davvero.
Cominciai a raccontare dall’inizio. Dissi degli autobus affollati, dei treni e dei villaggi illuminati dal tramonto, dissi dei fiumi splendenti e delle barche, delle zanzare e delle sanguisughe, dei tre grandi serpenti velenosi che più volte mi avevano morso alle caviglie mentre liberavo Aldo dalle macerie di un’immensa piramide nascosta nella giungla e crollata su di lui, dissi dei versi magici gridati da Carlos contro il cielo per salvarmi dalla morte del veleno, mentre mi guariva le ferite con impacchi di foglie e sangue d’animali, dissi delle formiche ronzanti che trascinavano uccelli interi fin dentro i loro nidi a forma di torre. Dissi questo e altro, e già mi preparavo a esagerare di più con quel che restava della storia quando la porta del Cafè dell’Avventura si spalancò, e vidi una donna entrare, e quella donna vestiva di rosso, e avanzò d’un passo, e la vidi sondare lo spazio con gli occhi in cerca di qualcuno, fin quando quegli occhi si piantarono su di me, e restarono su di me, e io allora troncai la frase che trattenevo tra i denti, e me ne rimasi a bocca spalancata a fissare la donna che mi guardava, e sperai che gli altri non si fossero accorti dell’improvviso frastuono del mio cuore.
Stella. Stella era sulla porta.
Lo so, Stella non l’avete mai vista, ed è per questo che ora non riuscite a capire perché, a trovarmela lì, immobile e inaspettata, non fui capace di controllare i salti del mio cuore impazzito.
Ma vi dico: Stella è una creatura splendente. Credetemi.
Cercai parole senza trovarne, poi cercai lo stupore nelle facce dei miei amici, ma guardandoli mi accorsi che nessuno era sorpreso per quell’arrivo e allora un pensiero mi colse: erano stati loro. Sapevano che Stella sarebbe venuta, erano stati loro, i miei compari, i vecchi cari bastardi amici del Cafè dell’Avventura che mi avevano spedito all’altro capo del mondo, e nel frattempo complottavano per costruire un miracolo.
Stella era tornata.
«Il resto della storia alla prossima…» è la sola cosa che riuscii a balbettare. E mi alzai dalla sedia. Ma nessuno protestò. E dagli altoparlanti del Cafè dell’Avventura un Chet Baker ruffiano pareva suonasse la sua tromba morbida apposta per me, per sostenermi degnamente quando mi avvicinai a Stella ancora ferma sulla porta. Era concentrata nei miei occhi, mi sorrise come una Gioconda, e io cosa avrei potuto fare quando la vidi muoversi per uscire, se non seguirla come avrei fatto con la Stella Polare se fossi stato un marinaio perso?
Ma prima mi voltai verso Peppuccio e gli dissi, solenne come per pronunciare un addio: «Stasera il caffè lo offro io. Per tutti. Ma mi raccomando, voglio il caffè più buono del mondo!» e indicai i due sacchi di caffè sul tavolo.
Poi uscii nella notte fredda. Stella mi stava aspettando. Per un po' camminammo nel buio. Stella non disse nulla. Io non le dissi nulla, ancora. Il cielo era pieno di stelle.
|