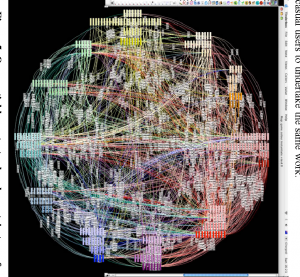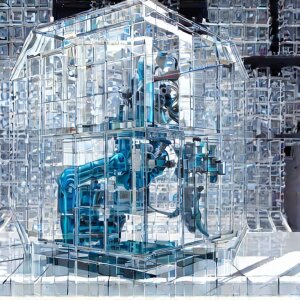|
Questa storia delle cascate da scalare non ce l’avevano raccontata. “È facile,” ci hanno detto, “mollate le jeep, camminate per un po’ e arrivate giusto in tempo per il salto”. Ora però capisco meglio come interpretare quelle parole: ci toccherà camminare per chissà quanto, lungo un sentiero sempre in salita, sotto a un sole di fuoco, tra rocce, sassi, terra, erba, polvere, ruscelli, piante urticanti, con assalti continui di puri-puri assetati del nostro sangue. E come se questo ancora non bastasse, adesso ci becchiamo le cascate.
Arrampicarsi, risalirle. Facile a dirsi, meno a farsi, quando ti devi aggrappare alle rocce bagnate e scivolose, mentre ti arrivano addosso ondate di acqua vaporizzata che ti impedisce anche di vedere dove metti i piedi. E sotto, trenta metri di rocce.
E di certo non ci consola vedere la destrezza di Hassan, la nostra guida: si arrampica come una scimmia, sparisce dentro nuvole d’acqua, riappare più in alto. Arriva in cima in tre minuti, si volta e ci sorride. Semplice per lui; non fa altro da quando è nato! È piccolo, visto da qua sotto. Ci osserva dall’alto come una sentinella.
Noi invece ci impieghiamo molto più di lui. È soprattutto Janet, l’americana, a metterci un secolo; è lenta e incapace, sposta le gambe grasse con la stolidità di un bradipo, e manda gridolini sgraziati quando si bagna, cioè sempre. Chissà perché certa gente si ficca volontariamente in situazioni come queste.
Anche Philip non è da meno dell’americana. Giovane, capelli rossi, magro come un chiodo, l’aria di chi si è perso. Mi pare sia belga. Guardandolo mentre si aggrappa con disperazione alle piante che sporgono dall’acqua mi viene da pensare che questa sia la prima volta per lui. Probabile non abbia mai visto altro che la sua terra: erbosa e piatta, piena di fiori, con grandi cieli piovosi. Ce la fa per un pelo a salire. Chiara invece se la cava benissimo, ha il passo sicuro, l’appoggio deciso, e non mi stupirei se scoprissi che è una di quelle che va in montagna la domenica. Mi cammina davanti mentre ci arrampichiamo. Alzo la testa e le ammiro il culo bagnato. Ogni tanto si gira a guardarmi come in cerca del mio consenso. Una ciocca di capelli umidi le cade sulla fronte. Ha degli occhi verdi molto belli.
Gli altri del nostro gruppetto non li conosco; facile che non avrò l’occasione di sapere chi sono. Alexandros, Cecìle, Klaus: solo nomi attaccati a delle facce. E di altri ancora non li ricordo neppure, i nomi. Ci ha unito questa camminata, e l’idea di lasciare per qualche giorno la città e le faccende di città. Oggi siamo impegnati a incarnare il ruolo dei turisti per bene, tutti assieme come a un raduno di antropologi dilettanti, stanchi ma soddisfatti, e pronti a ficcare il naso in quelli che non sono affari nostri. Domani saremo già dispersi, ognuno per la sua strada, stranieri l’uno all’altro come eravamo fino a ieri.
Dopo più di mezz’ora siamo tutti in cima alle cascate. Bagnati, e anche un po’ incazzati per la scalata imprevista. Noi che siamo arrivati per primi abbiamo avuto il tempo di star seduti ad asciugarci, gli altri invece non hanno questa fortuna. Aspettiamo gli ultimi del gruppo, una signora giapponese accompagnata da un marito grigio sempre silenzioso. Poi si riparte subito.
Per un’altra ora seguiamo il sentiero che corre a fianco del fiume. Ormai siamo in quota e camminare non è difficile. Il sole è impietoso, ma a volte riusciamo a infilarci tra le piante e grandi foglie palmate ci fanno ombra. E i puri-puri se ne sono andati, per fortuna, così smettiamo di agitarci come pazzi per scacciarli. Un coro di cicale e uccelli ci accompagna. A un tratto spunta da sopra l’acqua una farfalla rossa di dimensioni spaventose; ci gironzola attorno, poi sparisce dentro al verde.
Capisco che siamo vicini al villaggio prima ancora che Hassan ce lo dica. Si scorgono i tetti di paglia delle capanne. Già si intuiscono movimenti tra alberi in collina. Già sentiamo canti di donne.
Quattro cani dal pelo fulvo ci corrono incontro, si accostano per annusarci, poi scappano trotterellando. Attorno ci sono altri animali: capre tra i cespugli spinosi, un gruppetto di maiali neri, galline curiose e tori al pascolo.
Si suda parecchio in questa giornata d’estate. Bevo una sorsata dalla borraccia. Abbassando la testa verso l’orizzonte mi accorgo di uomini che avanzano verso di noi. Sono alti, possenti, e sembrano costruiti con un legno molto scuro; camminano in fila indiana, ci passano accanto ignorandoci. Ma la vista dei fucili che portano a tracolla di sicuro non ci aiuta a rilassarci dopo la fatica della scarpinata. Così, ancora intimiditi, ci avviciniamo a un gruppetto di donne riunite in cerchio attorno a un grande albero nero. Sembrano meno aggressive degli uomini armati. Alcune tengono in mano un lungo bastone e guardano il cielo, altre, inginocchiate per terra, si fanno truccare il viso con terre colorate e sistemare attorno alla vita lunghe fasce di tessuto grezzo.
Dopo poco, una di queste donne si scosta dal gruppetto. Decido di seguirla. Procede a piccoli passi, canta stonata agitando in aria il suo bastone. Deve essere lei la regina di questo momento: forse perché è incinta, forse perché è la più anziana, forse perché canta meglio delle altre. Difficile capirlo. Ma di certo è lei che comanda, e dietro di noi altre donne agghindate hanno preso a seguirla.
Presto siamo nel centro del villaggio, là dove la festa sembra già scatenata. Credo sia qui che le donne si fanno frustare per rendere indubitabile a tutti la loro capacità di sopportare il dolore. E infatti, quando arrivo al seguito della regina, mi accorgo che alcune donne hanno già preso i loro colpi: le schiene sono segnate da squarci profondi e da righe di sangue lucente. Ma ridono nonostante le ferite. Accettare il dolore, il sangue, la sudditanza: questo è il loro destino.
Quando ne ho abbastanza di vedere donne frustate mi sposto verso una piccola radura, distaccata dal villaggio. Lì trovo i guerrieri armati incontrati al nostro arrivo. Stanno danzando in cerchio. Dietro di loro, sullo sfondo, il sole costruisce fasce di terra luminosa. Ci sono alberi che sembrano grandi mani rovesciate, con le dita puntate verso l’alto, nere in controluce. Alcuni uomini si staccano dal cerchio e saltellano nel centro, incitati dagli applausi e dalle grida degli altri. Sono alti, belli, anche loro agghindati con fasce colorate in testa, e collane vistose, e buffe acconciature fatte di sabbia mescolata ai capelli. Cantano, battono le mani, concentrati per mantenere il tempo. I fucili sbattono sulle loro schiene lucide.
Torno verso il villaggio: qui tutto avviene ormai molto in fretta. Due grossi pentoloni appoggiati su un fuoco sono ricolmi di una birra oleosa che ribollendo sputa in giro un fumo bianco dall’odore aspro. Zucche piene di birra passano di mano in mano, di bocca in bocca, e l’alcol scalda presto l’umore di questo pomeriggio. Il sole è una grande sfera arancione che si abbassa verso l’orizzonte. Gli uomini bevono. I gesti sono sovrapposti. Le donne danzano, agitano le collane di campanelli, riempiono l’aria con i suoni squillanti delle loro trombe. Le voci sono sovrapposte. È così che doveva essere Babele.
Sono ore che danzano. Noi bianchi siamo dispersi, affascinati, stanchi. Il nostro gruppo non esiste più, ormai ciascuno si sposta per conto proprio, con lentezza. Per un momento scorgo la chioma rossa di Philip spuntare dietro al profilo di un toro al pascolo. Chiara ha preso a seguirmi, passo dopo passo, forse è il fatto che parliamo la stessa lingua a tenerci vicini, anche se ora non ci diciamo nulla, concentrati come siamo ad assorbire ogni istante di questa incredibile bolgia. Per un momento mi lascio distrarre dall’idea dei suoi occhi verdi.
Ci spostiamo tra i diversi nuclei di corpi ammassati. Difficile mantenere un fuoco d’attenzione su qualcosa di preciso. Miriadi di gesti mi catturano, si moltiplicano e si annullano tra loro. I colori e i suoni e i movimenti: sono vicino alla saturazione, poco abituato a questo eccesso di stimoli.
I guerrieri si sono uniti alla festa da tempo, preferendo la birra ai canti rituali. Guardo questi uomini ormai stremati, con le armi strette pericolosamente in mano e il passo da ubriachi; guardo le donne, con le schiene insanguinate, che ancora riescono a muoversi furiose e fanno ballare le tette; guardo altre donne che saltellano in piccoli gruppi festosi facendo vibrare le collane di campanelli: cantano con le bocche spalancate e i denti perfettamente bianchi, accostando i corpi e le teste come chicchi in un grappolo; guardo tre bambini che piangono abbracciati alle capre davanti a un cactus annerito dal fumo; più in basso, guardo gli uomini che preparano i tori per il salto: li afferrano per le corna come stringessero in mano volanti di grandi macchine di carne; li vedo trattenere gli animali tirandoli per le lingue, costringendoli stretti l’uno vicino all’altro. Poi vado in cerca con gli occhi di quel gruppo di gente bastarda che siamo noi, i turisti per bene, gli antropologi dilettanti, stranieri in una terra straniera, teste bianche distribuite tra le teste nere, noi che veniamo da tanti paesi diversi e ci siamo infilati qui a dentro a una festa che non è la nostra.
Però alla fine penso: adesso, questo villaggio nero e bianco è il centro perfetto del mondo. E anche noi, pur se solo per una frazione di tempo magico, per un miracolo che ci ha trascinati fin qui, anche noi adesso ne facciamo parte. Proiettati dritti fino al centro del mondo.
E finalmente è il momento che aspettavamo: il salto dei tori. Il ragazzo, il saltatore, è pronto. Eccolo lì, nudo e preoccupato che guarda le schiene delle bestie legate e in fila. Per lui è l’ora dell’entrata nel regno dei grandi, da conquistare facendosi una bella passeggiata sulle groppe dei tori. Certo, è un modo ben strano per dire al mondo che si è diventati adulti. E d’altra parte cosa possono pensare loro di noi, che per guardare questa fantastica follia il mondo l’abbiamo attraversato?
Le masse di gente rumorosa, gli animali ammucchiati, tutti i gesti, le grida, i pianti e le risate, tutto converge e trova una giustificazione nella scena davanti ai nostri occhi. Il ragazzo arriva da un lato, discretamente, quasi questo non fosse il giorno più importante della sua vita. Si fa strada tra le galline e le capre e le persone in festa; dopo una piccola rincorsa eccolo spiccare un salto verso i tori allineati. Tocca la schiena del primo col piede, si appoggia meglio per spingere il corpo in avanti, con le braccia aperte come fossero ali cerca un aiuto dell’aria per mantenere un equilibrio difficile. Salta rapido da una schiena all’altra, i tori storditi dalle grida subiscono quella camminata senza ribellarsi. Una schiena, poi un'altra e un'altra. Dodici tori in fila. C’è qualche esitazione nel passo del ragazzo, ma non cade.
Poi è dall’altra parte, con i piedi ben piantati a terra, finalmente. I tori alle spalle. Quindici secondi, non di più. Ha cominciato il salto che era un ragazzo, quando si lascia i tori indietro è già un uomo. E il villaggio intero, a questo punto, lo circonda. Cantano la gioia del suo passaggio riuscito.
Domani ci sarà un adulto in più tra loro. Domani le donne si cureranno le schiene martoriate con erbe e foglie. Domani magari qualcuno di loro morirà: per infezione, per vecchiaia, per il morso di un serpente, o di un ragno. Domani per noi sarà già tempo di tornare: tre ore di marcia, giù per le cascate, le jeep, strade di terra e poi il deserto, le periferie anonime di agglomerati urbani, un aeroporto. Indietro fino alle nostre città e alle faccende di città.
Mi allontano dal centro del mondo. Cammino a passi lenti verso le tende, lasciando indietro gli ultimi suoni della festa. Il sole è già tramontato e fatico a scoprire dove mettere i piedi. Chiara è di nuovo alle mie spalle, mi chiama. Mi giro e scorgo appena la sua sagoma. Immagino i suoi occhi verdi. Attorno c’è odore di muffa e di sterco animale. Sento il muggito di uno dei tori. Guardo in alto verso il cielo: è pieno di stelle.
|